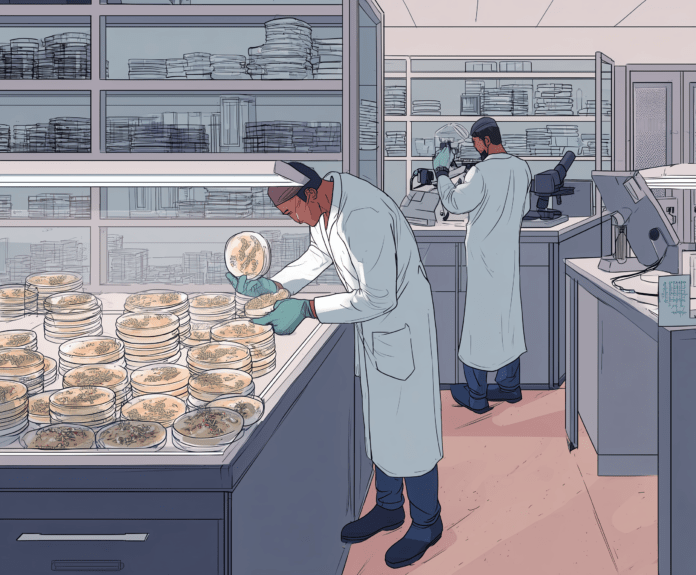Negli ultimi anni, il confine tra alimento e farmaco è diventato sempre più sottile; basti pensare agli integratori alimentari, che pur rientrando nella categoria degli alimenti sul piano normativo, spesso presentano formulazioni e funzioni molto simili a quelle dei medicinali. Il Regolamento europeo sui nuovi alimenti (“novel food”) insieme all’approccio sempre più rigoroso adottato dall’Autorità della sicurezza alimentare europea (EFSA) nelle sue linee guida, evidenzia come anche nel mondo regolatorio vi sia una crescente convergenza tra il settore alimentare e i principi tipici dell’ambito farmaceutico.
Il dossier Novel Food
Il Regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food definisce come “nuovo” qualsiasi alimento o ingrediente che non sia stato consumato in misura significativa nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997 (data che fa riferimento alla prima pubblicazione del Regolamento Novel Food, di cui l’ultima revisione è del 2015). Quando un alimento o un ingrediente rientra in tale definizione, è necessaria un’autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea prima della sua immissione sul mercato.
Dal punto di vista documentale, il soggetto richiedente è tenuto a presentare alla Commissione europea e all’Efsa un dossier tecnico completo, contenente una descrizione approfondita del novel food — inclusa la sua composizione, il processo produttivo e le modalità d’uso previste — accompagnato da un pacchetto di studi tossicologici condotti secondo gli standard internazionali (linee guida Oecd e coinvolgimento di laboratori certificati GLP). Questi studi devono coprire diversi endpoint, come la tossicità a breve e lungo termine, gli studi di Adme (Assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione), la genotossicità e l’eventuale presenza di effetti indesiderati, al fine di dimostrare, in modo inequivocabile, la sicurezza del prodotto per il consumatore. La ratio della normativa è chiara: garantire un elevato livello di sicurezza per il consumatore, attraverso un sistema centralizzato di valutazione del rischio gestito dall’Efsa.
Il pacchetto di studi tossicologici che il richiedente deve sottoporre all’Autorità è un pacchetto che prevede, obbligatoriamente in prima battuta, test di genotossicità in vitro (Oecd TG 471 o Oecd TG 487), uno studio di tossicità a dose ripetuta (Oecd TG 408) e alcuni studi di Adme (preliminarmente volti ad investigare l’assorbimento o meno del composto in esame).
Sulla base del parere scientifico di Efsa, la Commissione europea propone un atto di esecuzione che porta all’autorizzazione del prodotto all’interno del marcato dell’Unione.
Convergenze e divergenze con l’approccio farmaceutico
A conferma di un’evoluzione già evidente sin dalle prime versioni, che prevedevano una richiesta scientifica pre-clinica tutt’altro che marginale, la linea guida Efsa del 2024 – rispetto a quella del 2016 – introduce un rafforzamento significativo dei requisiti documentali, per esempio, per quanto riguarda la descrizione e la standardizzazione dei processi produttivi: viene posta maggiore enfasi sulla standardizzazione (e descrizione) del processo, sull’introduzione del concetto di “lot-to-lot consistency” per dimostrare la riproducibilità tra diversi lotti e sull’analisi approfondita di sottoprodotti di reazione, impurità e contaminanti potenzialmente generati. Inoltre, viene richiesto un livello più elevato di dettaglio sulle procedure di controllo qualità adottate lungo la filiera produttiva.
La terminologia impiegata nei pareri scientifici e nelle linee guida dell’Efsa riflette ulteriormente questa convergenza metodologica: si fa riferimento, ad esempio, a “modelli predittivi”, “effetti avversi”, “interazioni” e “meccanismi d’azione molecolari”, concetti propri del mondo farmaceutico. Anche nel caso di sostanze alimentari — come estratti vegetali, peptidi bioattivi o composti fermentati — l’Autorità richiede spesso la valutazione di effetti cumulativi, l’analisi di possibili interazioni con altri nutrienti o farmaci (drug-to-drug interaction) e la caratterizzazione dettagliata della loro azione a livello fisiologico.
Un diverso concetto di rischio
Va tuttavia ricordato che una distinzione fondamentale tra la regolamentazione farmaceutica e quella alimentare risiede nel diverso approccio al concetto di rischio. Nel settore farmaceutico, la valutazione è basata su un bilancio tra rischi e benefici: un medicinale può essere autorizzato anche se comporta effetti collaterali, purché i benefici terapeutici superino chiaramente i potenziali danni. Al contrario, in ambito alimentare – e in particolare nel contesto dei novel food – il principio guida è quello del “rischio zero”. L’alimento deve dimostrarsi sicuro per tutte le categorie di popolazione, in tutte le condizioni di consumo previste, senza la possibilità di accettare un rischio residuo, per quanto minimo.
Critiche e prospettive
Una prima perplessità a questo approccio sempre più farmaceutico è relativa al concetto di “rischio zero” (traducibile, dal regolatore, come “pericolo zero” più che “rischio zero”). L’adozione di un approccio metodologico così rigoroso comporta un approfondimento molto spinto degli aspetti tossicologici e metabolici degli ingredienti alimentari, al punto che anche sostanze ritenute sicure possono talvolta generare segnali marginali in scenari espositivi altamente improbabili o in condizioni sperimentali estreme. In un sistema fondato sul principio del rischio zero, tuttavia, anche evidenze deboli o teoriche possono risultare sufficienti a pregiudicare l’esito positivo della valutazione da parte dell’Autorità.
In seconda battuta, una valutazione approfondita della sicurezza comporta anche una notevole complessità tecnico-scientifica. La necessità di trattare gli ingredienti alimentari come principi attivi richiede competenze trasversali, dossier articolati e studi approfonditi, con un conseguente aumento dei costi e degli oneri procedurali. Questo tende a favorire operatori strutturati, rendendo più difficile l’accesso al mercato per le piccole imprese o per chi opera con pratiche produttive tradizionali.
L’equilibrio tra sicurezza e sviluppo
La crescente complessità del quadro regolatorio applicato ai novel food riflette, da un lato, l’intento legittimo delle istituzioni europee di garantire la massima sicurezza per il consumatore; dall’altro, introduce dinamiche che avvicinano sempre più il settore alimentare a quello farmaceutico, tanto sul piano scientifico quanto su quello procedurale. Se da un lato questa convergenza può favorire una maggiore standardizzazione e affidabilità, dall’altro solleva interrogativi sulla proporzionalità degli strumenti adottati rispetto alla natura e alla funzione degli alimenti. In un contesto in cui innovazione e sostenibilità rappresentano priorità strategiche, sarà cruciale trovare un equilibrio che consenta di tutelare la salute pubblica senza ostacolare l’evoluzione del comparto alimentare né appiattirne la diversità culturale e produttiva.