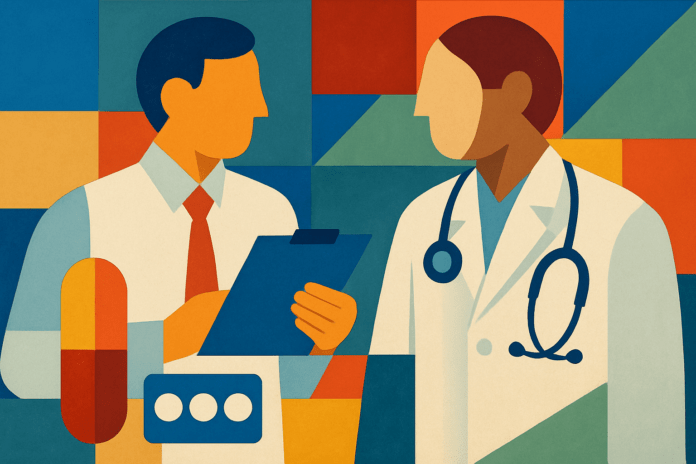Una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 3437 del 15 ottobre 2024, offre lo spunto per tornare a ripensare la figura dell’informatore scientifico del farmaco (ISF) in un contesto lavorativo e organizzativo che negli ultimi anni è stato caratterizzato da importanti tendenze al cambiamento dei modelli lavorativi, sempre più improntati a forme maggiormente “agili/smart” di organizzazione del lavoro, tuttavia in quadro regolatorio rimasto sostanzialmente immutato (spesso non tanto per esigenze di compliance legislativa quando di efficacia del modello lavorativo e, a volte, di resistenze sul fronte sindacale. Il riferimento è alla modalità di informazione scientifica svolta da remoto, durante il periodo emergenziale).
L’informatore scientifico del farmaco
Come noto, l’informatore scientifico del farmaco è una “figura professionale” regolamentata, in primis, dal Codice del Farmaco (D.lgs. 219/2000 – anche solo CdF), che all’art. 122 affida all’ISF (e solo a questo) l’attività di informazione sui medicinali in favore di medici e farmacisti.
La c.d. promozione di specialità medicinali è, quindi, attività “riservata” (agli ISF) e di conseguenza rigorosamente disciplinata. Lo è ad esempio rispetto all’obbligo dell’ISF di essere in possesso di uno specifico titolo di studio, tra quelli ammessi dall’ordinamento, o di lavorare “in esclusiva” per una sola azienda farmaceutica, o meglio “sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un’unica impresa” (art. 122, co. 3, CdF, con tutti i conseguenti profili critici/interpretativi rispetto, ad esempio, a ISF agenti non in mono committenza ovvero a forme di esternalizzazioni a linee non dedicate/esclusive di informatori).
Come noto, l’informazione scientifica a cura degli ISF è l’attività attraverso cui le aziende promuovono i propri medicinali nel rispetto di un quadro regolatorio che mira a garantire una corretta informazione sui medicinali e, più in generale, la tutela della salute pubblica. Ed è proprio quest’ultima finalità di interesse generale che ne giustifica la rigorosa regolamentazione.
Oltre agli obblighi accennati sopra, il CdF contiene, infatti, ulteriori disposizioni sulle modalità e gli strumenti attraverso i quali gli ISF possono operare, come ad esempio il materiale informativo, il materiale promozionale (artt. 119 e 120, CdF) e i campioni gratuiti (art. 125, CdF). In tale contesto, è anche previsto il divieto di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista (art. 123, co. 1, CdF).
Nell’ambito del quadro normativo dettato dal CdF si inseriscono, inoltre, ulteriori regole e norme comportamentali dettate dal Codice deontologico di Farmindustria che specificano ulteriormente gli obblighi di compliance a carico degli ISF.
Vale infine la pena menzionare che nell’ambito dell’esercizio dell’attività degli ISF si annidano anche rischi di commissione di diverse fattispecie di reato (quali, ad esempio, la corruzione o la truffa) presupposto per l’insorgere di una responsabilità amministrativa in capo agli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, gestendo infatti gli ISF assidue e delicate relazioni con personale medico e farmaceutico, appartenenti non solo al mondo privato ma anche (e soprattutto) al settore pubblico.
Tali rischi richiamano senz’altro la necessità di identificare e adottare idonei sistemi special preventivi di compliance aziendale da calare nello specifico settore di riferimento e pertanto, tra gli altri, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 ispirati al rispetto del già citato Codice deontologico, della normativa applicabile e delle indicazioni di Farmindustria riferibili all’attività in esame (cfr. “Documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione scientifica”, Farmindustria, 2022).
Aspetti di natura giuslavoristica
Da un punto di strettamente giuslavoristico, la posizione lavorativa dell’ISF subisce condizionamenti dal fronte regolatorio, a partire dal “doppio” livello di dipendenza che connota tale figura, da un lato gerarchicamente inserita nella struttura organizzativa e, quindi, a riporto di figure come i Capi Area/District Manager/Area Manager (a seconda della dimensione e della conformazione “organigrammica” dell’azienda farmaceutica di riferimento) e, dall’altro, rigorosamente a riporto del Responsabile del Servizio Scientifico, seppur nell’accezione, oggi comunemente accettata, del c.d. riporto funzionale.
Sempre sul piano del rapporto lavorativo non vi sono dubbi neppure sul fatto che il corretto e diligente adempimento della prestazione lavorativa dell’ISF non può prescindere dall’obbligo di conformare il proprio operato alle regole del settore di riferimento, al fine di permettere alle aziende farmaceutiche di adempiere ai propri obblighi derivanti dalla normativa di settore.
Ciò vale, ad esempio, con riguardo all’obbligo di comunicare all’AIFA il numero dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici, specificando il numero medio di visite effettuate. Informazione, questa, che passa per la comunicazione all’AIFA anche dell’elenco degli informatori scientifici impiegati nel corso dell’anno precedente, con l’indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l’azienda farmaceutica, in un’ottica di “mappatura” costante dei flussi connessi alle attività di promozione dei medicinali.
Peraltro, lo tesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Chimico Farmaceutico (CCNL) che, salvo alcune eccezioni, rappresenta quello maggiormente applicato nel “comparto”, nella descrizione della figura professionale dell’ISF e, quindi, nella enunciazione delle mansioni, dalla quali è poi possibile ricavare il perimetro della diligenza professionale che un’azienda è legittimata a pretendere da un proprio ISF, fa un esplicito rimando proprio al CdF e, quindi, al “rispetto del D.Lgs. 30/12/1992 n. 541 come modificato dal D.Lgs. 24/04/2006 n. 219”.
La recente sentenza della Corte di cassazione
Da tali premesse muove la decisione della Corte di cassazione, con la sentenza qui in commento, di ritenere legittimo il licenziamento intimato ad un ISF licenziato per giusta causa, all’esito di una indagine investigativa avviata dalla società datrice di lavoro, dalla quale era emerso che il lavoratore non aveva visitato tutti i medici che lo stesso aveva invece indicati nel report mensile trasmesso alla società.
Nel giudicare la condotta tenuta dall’ISF in questione, la Corte ha valorizzato alcuni aspetti che sono propriamente connaturati alla figura dell’informatore, a partire dall’elevato grado di autonomia operativa nell’organizzazione delle visite da effettuare nell’ambito del territorio assegnato, che è tale al punto che, comunemente, l’ISF è ritenuto essere il “manager” del proprio territorio e, quindi, il fatto di aver profittato di tale autonomia per rendere informazioni false o non complete alla propria azienda (che appunto è stata costretta ad incaricare un’agenzia investigativa per controllare la corretta esecuzione della prestazione da parte dell’ISF).
Interessante anche il richiamo non solo agli obblighi propri di qualunque rapporto di lavoro subordinato, tra cui quello di diligenza (art. 2104 c.c.), in forza del quale “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta“, ma anche ai doveri specifici derivanti dalla normativa regolatoria del settore di riferimento, tra cui il predetto obbligo, posto in capo alle aziende farmaceutiche, di rendicontazione all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), si intende in modo fedele e completo, il numero di medici visitati, sulla base dei dati comunicati dai propri informatori.
Conclusioni
Come confermato dalla sentenza in commento, l’ISF riveste un ruolo centrale – oltre che “unico” nel quadro normativo di riferimento – ma al contempo critico nel contesto organizzativo e di impresa delle società farmaceutiche. È evidente come le aziende, nella gestione dei propri ISF debbano, appunto, tenere in considerazione sia gli aspetti regolatori che i profili di natura giuslavoristica che caratterizzano tale figura, che a tratti possono anche sembrare confliggenti ma dai quali non si può prescindere in un esercizio teso al raggiungimento degli obiettivi di compliance, che richiede necessariamente la pianificazione e l’adozione di procedure e presidi di verifica atti a identificare e mitigare i diversi fattori di rischio connessi al rispetto della ampia e variegata disciplina applicabile.