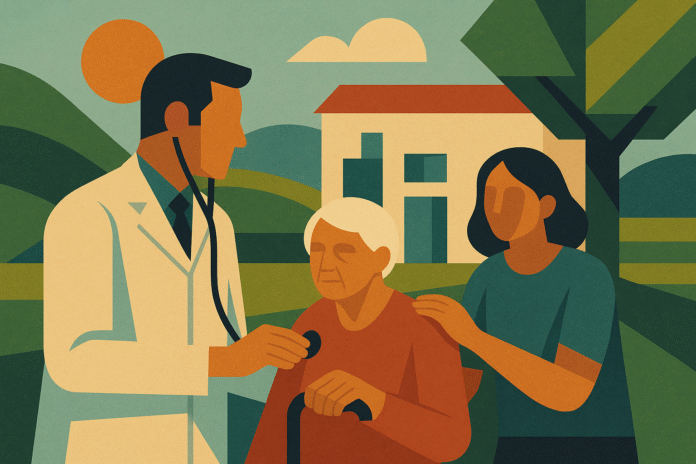Nel 2023 la spesa sanitaria complessiva in Italia ha raggiunto 176 miliardi di euro: 130 pubblici e 46 privati. Solo il 74 % della spesa è pubblica, contro una media OCSE del 79 %. La quota privata out-of-pocket pesa per il 23 % — una delle più alte d’Europa — segno che il cittadino finanzia di tasca propria sempre più servizi territoriali.
In rapporto al PIL, la spesa sanitaria pubblica italiana è scesa al 6,3 %, contro il 6,9 % medio europeo. La spesa pro-capite (3.835 USD) resta sotto la media OCSE (4.625 USD). Mentre gli altri Paesi investono per rafforzare l’assistenza di prossimità, in Italia la spesa per la prevenzione è calata del 18,6 % tra il 2022 e il 2023 (Fonte: Osservatorio GIMBE, 2025).
Nel frattempo, la domanda cresce. Gli over 65 superano i 14 milioni (24 % della popolazione) e le malattie croniche interessano oltre 12 milioni di cittadini. È su questo fronte che la sanità territoriale dovrebbe intervenire — continuità assistenziale, domiciliarità, presa in carico — ma proprio qui il sistema mostra le sue crepe più profonde.
L’offerta territoriale: poche strutture, grandi divari
Secondo il “Panorama della Sanità 2023”, il SSN dispone di 194 mila posti letto ospedalieri (3,6 ogni 1.000 abitanti) e di circa 327 mila in strutture residenziali o semiresidenziali. Ma la distribuzione è fortemente diseguale: nel Nord-Est si contano 10 posti letto socio-assistenziali ogni 1.000 abitanti, nel Sud appena 3 (ISTAT 2023).
Le nuove strutture previste dal DM 77 procedono lentamente. Al 2024 si contano:
- Case della Comunità: circa 400 operative (di cui 121 in Emilia-Romagna);
- Centrali Operative Territoriali: 590 attive;
- Ospedali di Comunità: 120 (da 57 nel 2023).
Numeri che testimoniano un avvio, ma ancora lontani dagli obiettivi del PNRR (1.350 Case della Comunità e 400 Ospedali di Comunità entro il 2026). La disomogeneità territoriale resta ampia: solo alcune regioni — Emilia-Romagna, Toscana, Veneto — mostrano reti integrate e governance stabili.
Le criticità principali rimangono strutturali:
- carenza di personale, in particolare infermieristico (6,2 infermieri per 1.000 abitanti contro 9,2 media OCSE);
- scarsa integrazione socio-sanitaria;
- digitalizzazione ancora incompleta e cartelle cliniche non interoperabili;
- scarsa attrattività delle professioni territoriali.
I LEA e la “geografia dell’inadempienza”
Secondo l’ultimo monitoraggio LEA 2023, otto regioni non garantiscono pienamente i livelli essenziali di assistenza. L’area più critica è proprio quella territoriale-distrettuale, dove un terzo delle regioni resta sotto la soglia di sufficienza. Al contrario, l’assistenza ospedaliera ottiene punteggi più uniformi, segno che l’Italia continua a essere “ospedalocentrica”.
La qualità dell’assistenza territoriale dipende in larga parte dalle capacità regionali: quelle con una governance consolidata (es. Emilia-Romagna, Veneto, Toscana) ottengono buoni risultati; altre, soprattutto del Mezzogiorno, scontano ritardi nella rete distrettuale, nei servizi domiciliari e nei programmi di prevenzione.
Il confronto con l’Europa
L’Italia spende meno e concentra più risorse sull’ospedale. Nel 2023, l’assistenza ospedaliera ha assorbito il 29,4 % della spesa sanitaria, contro una media UE del 27,6 %. L’assistenza ambulatoriale e domiciliare è finanziata pubblicamente solo al 61,6 %, mentre in Germania e Francia la quota supera l’80 %.
Nella long-term care (assistenza a lungo termine per non autosufficienti), l’Italia destina il 9,8 % della spesa sanitaria, contro il 16 % della media europea.
In paesi come Francia, Regno Unito e Scandinavia, la medicina territoriale si fonda su reti multiprofessionali: primary care networks, health centers e équipe integrate con forte presenza infermieristica e sistemi digitali interoperabili. L’Italia, invece, resta ancorata a un modello frammentato, in cui la presa in carico cronica dipende ancora troppo dal singolo medico di medicina generale.
PNRR e DM 77: la promessa (ancora) sospesa
Il DM 77/2022 ha introdotto standard nazionali per l’assistenza territoriale: una Casa della Comunità ogni 50.000 abitanti, una Centrale Operativa ogni 100.000, un Ospedale di Comunità ogni 150.000. Il PNRR ha stanziato circa 7 miliardi per la loro realizzazione, ma al 2025 gran parte dei progetti è ancora in fase di cantiere o di progettazione esecutiva.
Le difficoltà principali riguardano il reperimento del personale e la gestione regionale delle risorse. Molte Regioni non dispongono ancora di infermieri di famiglia e di comunità a regime, e le nuove strutture rischiano di rimanere “scatole vuote”.
Serve una governance nazionale forte per garantire uniformità, definire modelli di finanziamento orientati agli esiti (non solo alle prestazioni) e monitorare i risultati in termini di accesso, continuità e soddisfazione del paziente.
Il futuro prossimo: spostare l’asse verso la persona
Il futuro dell’assistenza sanitaria italiana si gioca sul territorio. Ma la trasformazione non può ridursi a un piano edilizio: occorre un cambio di paradigma.
Significa:
- integrare pienamente sanitario e sociale;
- investire sul capitale umano territoriale;
- utilizzare il digitale per coordinare dati, percorsi e follow-up;
- premiare i risultati di salute e non solo la produzione di prestazioni;
- coinvolgere il cittadino nella gestione del proprio percorso di cura.
Come osserva l’Osservatorio sulla Salute (2024), l’Italia è “nel mezzo del guado”: ha riconosciuto che il futuro della sanità è nella prossimità, ma non ha ancora trasformato questa consapevolezza in sistema.
Quale domani?
L’assistenza territoriale è la frontiera che separa il SSN del passato da quello del futuro. Senza un radicamento reale nel territorio, l’ospedale continuerà a essere la risposta standard a ogni bisogno di salute — e quindi il simbolo dell’inefficienza.
Il PNRR e il DM 77 hanno indicato la strada; ora servono governance, personale e continuità politica. Solo così il “territorio” potrà smettere di essere il punto debole del sistema e diventare il suo vero motore di sostenibilità.