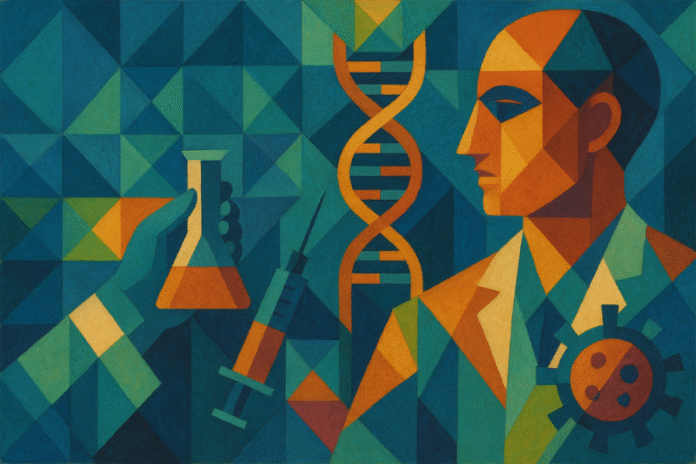L’esplosione delle biotecnologie negli ultimi 30 anni, a partire dall’avvio del Progetto Genoma Umano, è stata inarrestabile. E oggi che possiamo affermare di essere entrati nella terza era della genomica, le prospettive non potrebbero essere più ampie e promettenti. L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha dato la parola a 66 esperti del settore provenienti da 32 Paesi per definire quali saranno gli sviluppi e gli avanzamenti tecnologici più probabili nei prossimi anni. Lo scenario che si è venuto ad aprire è ricco e a tratti sorprendente.
Breve termine (1-5 anni)
Nell’immediato futuro, gli strumenti di editing genomico di nuova generazione apriranno la strada a modifiche sempre più precise, direzionate a più siti genomici contemporaneamente. Più accurate, efficienti e versatili, queste tecniche medieranno riprogrammazioni genetiche complesse alla base di nuove specialità terapeutiche, riducendo al contempo gli errori di processo.
I progressi nel sequenziamento e nella sintesi del Dna permetteranno inoltre una riduzione dei tempi e dei costi, aumentando l’accessibilità a questo genere di processi e facilitando, insieme alle innovazioni nella sintesi enzimatica e nella fermentazione, l’ingegnerizzazione di microrganismi nuovi o con nuove caratteristiche, che possano produrre molecole di interesse mai ottenute in precedenza o diventare inediti probiotici.
Anche la lotta contro cancro, malattie rare e malattie genetiche potrà vedere avanzamenti significativi grazie allo studio dei profili genetici dei pazienti e alla messa a punto di terapie personalizzate e di precisione. E il costo di queste applicazioni andrà probabilmente incontro a una riduzione mano a mano che le tecnologie necessarie, come l’ingegnerizzazione delle cellule immunitarie, verranno perfezionate.
Infine, importanti passi in avanti sono probabili nel contrasto a due pericolosi fenomeni: l’antimicrobicoresistenza e l’insorgere di virus ad alto potenziale pandemico. Nel primo caso lo sviluppo di alternative agli antibiotici, come terapie basate su batteriofagi ingegnerizzati, potranno fornire una strada alternativa. Nel secondo, lo sviluppo di vaccini di terza generazione, come quelli a base di Rna, e uno sforzo congiunto a livello globale potranno contrastare il fenomeno salito alla ribalta a partire da Covid-19.
Il Pabs è pensato per dare una veste pratica alla sinergia tra Paesi ad alto e basso reddito richiesta per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo pandemico globale. In questo senso, particolare importanza è data ai vaccini, il cui sviluppo a partire da dati genomici ha avuto uno slancio enorme da Covid-19 in poi, anche grazie all’avanzamento delle tecnologie di sequenziamento che hanno portato a riduzioni dei tempi e dei costi del processo. Inoltre, la possibilità di sequenziare il genoma virale a partire da un ridotto quantitativo di materiale e l’accesso a banche dati sempre più ampie, complete e condivise rende la produzione di vaccini di terza generazione ancora più accessibile.
Diffusione dei vaccini per evitare nuove pandemie
Nonostante l’Italia sia stato uno degli 11 Paesi astenuti, a maggio l’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato il nuovo “Accordo pandemico globale” con 124 voti favorevoli. L’obiettivo generale del documento è il miglioramento della prevenzione e dell’eventuale risposta a future pandemie, lavorando sulla preparazione in modo continuativo e congiunto. Per farlo, l’accordo promuove l’inserimento dell’approccio One Health di integrazione di salute umana, animale e ambientale nelle politiche nazionali e la creazione di una rete di logistica e di approvvigionamento globale efficace. Un ulteriore nodo fondamentale dell’Accordo è il potenziamento dei sistemi sanitari nei Paesi che potrebbero essere con più facilità focolaio di nuove infezioni e che sono spesso a basso reddito. Oltre al miglioramento delle capacità di ricerca su scala locale, la produzione e la diffusione dei vaccini è un punto cardine di questo processo. In tal senso l’Accordo prevede l’utilizzo dello strumento Pabs (Pathogen access and benefit-sharing system), che obbliga le aziende farmaceutiche interessate all’accesso ai dati sui patogeni emergenti in un certo territorio a donare al Paese coinvolto una quota equa di vaccini, strumenti diagnostici e farmaci sviluppati grazie a quel materiale: si tratta di almeno il 20% della produzione, con un minimo del 10% a titolo gratuito e il resto a prezzi accessibili.
Medio termine (5-10 anni)
Secondo il panel degli intervistati, anche a medio termine si continueranno a vedere i benefici del miglioramento nella sintesi del Dna e della bioingegneria in termini di riduzione di costi e aumento dell’accessibilità, anche grazie all’auspicata nascita di una rete globale di organizzazioni che si occupano di biologia sintetica.
Proprio l’ingegnerizzazione di materiale vivente potrà infatti vedere miglioramenti sorprendenti che vanno oltre la possibilità di far produrre nuove molecole a organismi geneticamente modificati, portando al loro utilizzo in nuovi ambiti, come la moda, le costruzioni o l’elettronica. Inoltre, l’ingegnerizzazione delle comunità microbiche umane, come quelle di intestino o bocca, potrà aumentare l’efficacia dei trattamenti delle malattie in queste aree, mentre una novità nell’ambito della diagnostica potrà derivare dalla produzione di biosensori per il rilevamento di particolari sostanze contaminanti, patogeni o cellule degenerate direttamente in situ.
Proprio le tecnologie per agire in situ vedranno altre significative novità. Cellule opportunamente modificate impiantate nei tessuti viventi potranno inviare segnali a quelle circostanti, con benefici inediti nella guarigione delle ferite, nella diagnostica o nella somministrazione di farmaci. Un campo, quest’ultimo, che potrà beneficiare anche di altre innovazioni, come l’utilizzo di vettori non virali per il trasporto di frammenti di acidi nucleici o proteine.
Dal punto di vista strettamente medico bisogna poi considerare i passi da gigante attesi nell’ambito degli xenotrapianti, in cui gli organi provengono cioè da specie non umane.
Come non aspettarsi, infine, avanzamenti da parte di discipline recenti quali la biologia quantistica, che prende in prestito i principi della chimica teorica e della meccanica, o le tecnologie omiche spaziali, il cui obiettivo è studiare le molecole biologiche in vivo all’interno del tessuto di provenienza.
Xenotrapianti, dalla fantascienza alla realtà
L’idea di utilizzare altre specie animali come fornitrici di organi da trapiantare non è nuova, ma per molti anni le difficoltà di un simile processo hanno superato i possibili benefici. Oggi comincia a non essere più così.
Le principali problematiche da superare in questo ambito sono quelle legate ai fenomeni di rigetto. Una difficoltà è infatti posta dalla presenza di agenti patogeni, soprattutto virus, tipici della specie coinvolta: è stata proprio questa la motivazione del rigetto che ha causato il decesso del secondo paziente al mondo a ricevere un cuore di maiale, nel 2023. Altra causa di rigetto possono essere le differenze genetiche tra specie. A tal proposito vi è ora la possibilità di sfruttare la tecnologia Crispr per eliminare quei geni che determinano l’incompatibilità interspecifica e inserirne invece altri tipici della specie umana. Questo processo riduce di molto la probabilità di rigetto e viene eseguito ad esempio da aziende biotecnologiche come la statunitense eGenesis, che lo utilizza per ottenere embrioni di maiale geneticamente modificati per sviluppare reni più simili a quelli umani, da impiantare in scrofe i cui cuccioli diventeranno donatori. Un rene ottenuto con questa procedura è stato trapiantato nel gennaio di quest’anno e, al meglio delle conoscenze disponibili al momento della scrittura di questo articolo, il paziente che l’ha ricevuto non ha subito alcun rigetto e anzi si trova in buone condizioni di salute.
Ma perché affrontare tutte queste difficoltà? Il principale motore che spinge la sperimentazione sugli xenotrapianti è da ricercarsi nella carenza cronica di organi. La richiesta di trapianti nel mondo è generalmente molto maggiore rispetto alla disponibilità di organi, inasprendo i criteri di esclusione e generando liste di attesa che possono diventare esageratamente lunghe. Nel caso del rene e del fegato, inoltre, si aggiunge il problema della qualità degli organi da trapiantare, maggiore se il donatore è vivo piuttosto che se il materiale viene prelevato da un donatore deceduto.
Lungo termine (oltre i 10 anni)
Ma è il futuro più lontano a riservarci le possibilità più sorprendenti. L’editing genomico avanzerà ulteriormente e aprirà quindi un panorama ancora in parte imprevedibile. In questo contesto, l’ingegnerizzazione di cellule e microrganismi potrà mettersi al servizio diretto della medicina, producendo entità viventi che siano esse stesse il farmaco, aumentando così la compliance terapeutica e diminuendo la necessità di somministrazioni frequenti o comunque ripetute.
La biologia cellulare potrà invece in un certo senso bypassare gli studi in vivo, grazie alla creazione di cellule artificiali completamente autonome e funzionali, da utilizzare sia come modelli per comprendere meglio i processi biologici sia come fabbriche di molecole. Nel futuro, però, non vediamo solo cellule artificiali, ma anche tessuti e organi, prodotti con l’utilizzo di tecniche già note come la stampa 3D, la manipolazione delle cellule staminali o la produzione di organoidi a fini di studio e ricerca.
Infine, lo studio sempre più approfondito del Dna e delle sue potenzialità potrà fornire un metodo alternativo di stoccaggio dei dati. La natura ci ha fornito una molecola fatta apposta per immagazzinare informazioni, con un codice crittografato perfetto nella sua semplicità. Il suo utilizzo pratico certo pone grandi criticità, ma gli avanzamenti nello studio dei semiconduttori, ancora una volta basati su materiale biologico, potranno fornire un aiuto.
É proprio il caso di dire allora “sky is the limit“… Anzi no, perché tra le future applicazioni biotecnologiche ci sono anche i progetti che riguardano le prossime missioni spaziali di colonizzazione di nuovi mondi e produzione di cibo su altri pianeti. Forse allora il limite è solo quello che ci poniamo noi.
Hard disk biologici: perché no?
Dati, dati e ancora dati. Ne siamo sommersi e la necessità di archiviarli pone sempre maggiori sfide. A scuola impariamo che il ruolo del Dna è immagazzinare le informazioni necessarie a costituire un individuo… ma allora perché non utilizzarlo come sistema di stoccaggio delle informazioni? L’eleganza e la semplicità dell’idea sono disarmanti: abbiamo inventato sistemi di archiviazione sempre più complessi quando la natura ci aveva già fornito tutto il necessario. Beh, non proprio tutto.
L’idea di utilizzare il Dna come strumento di conservazione, infatti, pur non essendo nuova, ha preso forma solo dopo la scoperta delle potenzialità della tecnologia Crispr. Il primo rivoluzionario studio, condotto da un gruppo di ricerca della Harvard medical school e pubblicato su Nature, risale al 2016. In quell’occasione i ricercatori hanno tradotto l’informazione digitale contenuta nei pixel di un’immagine e in una serie di fotogrammi in un codice a Dna, che è stato inserito in una sequenza non codificante di un genoma batterico. In questo modo hanno dimostrato che il sistema Crispr può codificare informazioni di una certa complessità all’interno di cellule viventi. Non solo: l’informazione è stata poi richiamata e si sono potute riottenere l’immagine digitalizzata di una mano stilizzata e la serie di fotogrammi che rappresentano un cavallo al galoppo scelte per l’esperimento, proprio come se si stesse leggendo un hard disk.
Quali sarebbero i vantaggi di un tale avanzamento tecnologico, che negli anni successivi è stato approfondito e perfezionato? Innanzitutto la vita degli hard disk biologici, che virtualmente possono rimanere intatti per migliaia di anni. In secondo luogo lo spazio occupato, visto che un grammo di Dna potrebbe contenere 215 milioni di gigabyte di informazioni. Certo sono necessari avanzamenti per superare gli ostacoli posti dai costi ancora troppo elevati e dalla ridotta velocità del processo, ma le applicazioni reali potrebbero essere più vicine di quanto ci aspettiamo.