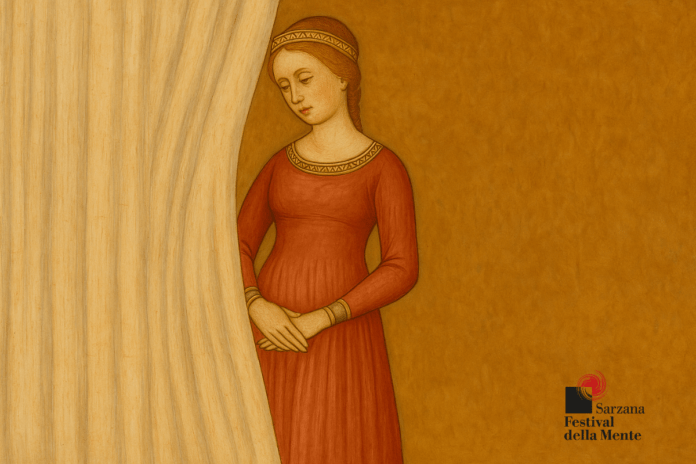Al Festival della Mente di Sarzana 2025, dedicato al tema dell’“invisibile”, lo storico Alessandro Barbero ha affrontato una questione che tocca tanto la storia quanto il nostro presente: “Invisibili? Le donne nel Medioevo“.
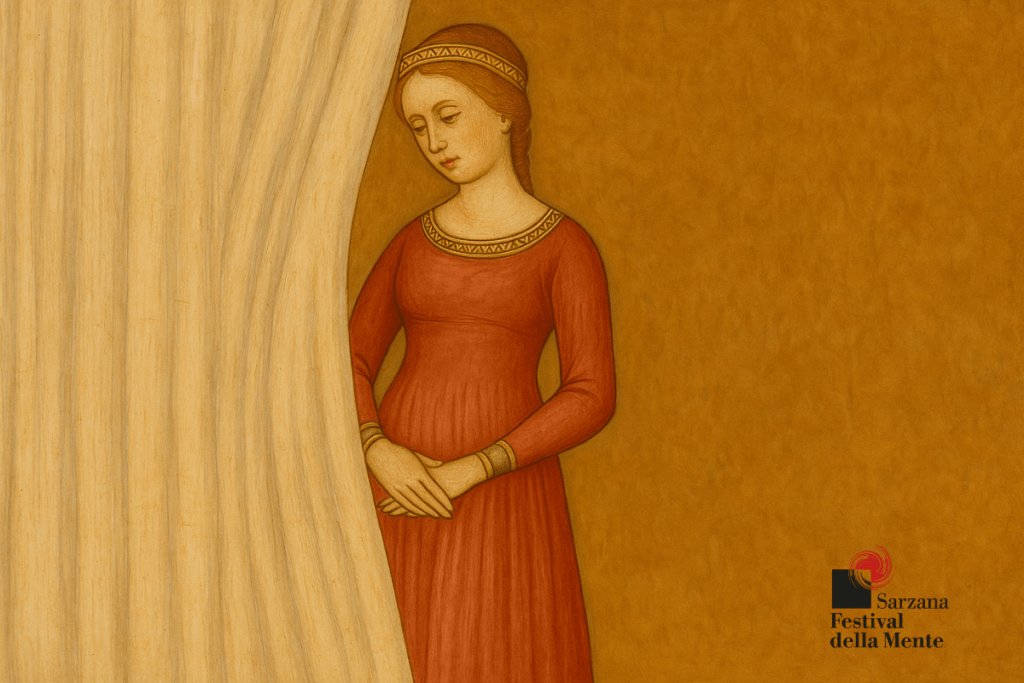
L’idea che le donne medievali fossero del tutto marginali è, secondo Barbero, una distorsione. Non erano assenti: erano presenti nella vita quotidiana, centrali nella famiglia, nella cura, nell’economia, persino nella politica. Ma sono diventate invisibili perché chi scriveva le cronache, le leggi e la letteratura ufficiale erano uomini, e le loro voci sono state filtrate da quello sguardo.
Compiti esclusivi e centralità sociale
Le donne medievali avevano compiti esclusivi: la nascita era un mondo interamente femminile, affidato alle levatrici; la cura di malattie e ferite domestiche si basava su saperi tramandati da erboriste e guaritrici. Erano loro, inoltre, a gestire terre e patrimoni quando gli uomini partivano per guerre o crociate.
Questi ruoli non erano marginali: erano indispensabili per la sopravvivenza delle comunità. Il fatto che non trovino spazio nelle cronache non dipende dalla loro assenza, ma dal filtro maschile della memoria scritta.
Letteratura come specchio: dal Decameron alla Commedia
Barbero ha ricordato come la letteratura coeva dimostri, al contrario, quanto fosse normale attribuire alle donne ruoli attivi. Boccaccio, nel Decameron, immagina sette giovani donne e tre uomini che, durante la peste del 1348, si ritirano in campagna e si raccontano storie. Le donne sono maggioranza, protagoniste, narratrici e giudici morali delle novelle.
Se un intellettuale del Trecento poteva concepire una cornice del genere, è segno che la loro voce era ben presente e plausibile agli occhi dei contemporanei. Altro che invisibili.
Lo stesso vale per Dante. Nella Divina Commedia, è Beatrice a guidare il poeta verso la salvezza. E accanto a lei compaiono altre figure femminili potenti: la Vergine Maria e Santa Lucia, che intercedono per l’anima di Dante. Le donne sono descritte come forze decisive, capaci di orientare la storia spirituale e politica dell’epoca.
Questo mostra che le fonti letterarie più alte del Medioevo non solo riconoscevano un ruolo alle donne, ma le collocavano in posizioni di autorità morale e simbolica.
Una santa che parla ai potenti
Tra le figure storiche, Barbero ha richiamato Santa Caterina da Siena. Nonostante l’assenza di diritti politici formali, Caterina esercitò un’influenza diretta sulla Chiesa e sul papato, intervenendo in questioni diplomatiche e religiose cruciali per il suo tempo. Una donna senza titoli ufficiali, ma con un potere reale: visibile nella pratica, invisibile nelle categorie formali del potere.
Lo sguardo degli altri: donne “troppo libere”
Interessante anche lo spunto comparativo: alcuni cronisti musulmani descrivevano le donne dei Franchi come insolitamente libere, persino eccessive nei loro comportamenti pubblici. Questo contrasto culturale rivela quanto l’invisibilità sia relativa: ciò che un mondo considera normale, un altro lo giudica scandalosamente visibile.
Dati mancanti, cure mancanti
Il parallelo con le scienze della vita è evidente. Anche nella medicina moderna, le donne non erano assenti, ma sono state rese invisibili dalle scelte di chi costruiva i dati. Per decenni i trial clinici si sono concentrati sugli uomini, escludendo le donne come “variabili complicanti”.
Il risultato è stato lo stesso della storiografia medievale: una realtà parziale, che ignora metà della popolazione. Farmaci calibrati su corpi maschili, effetti collaterali sottovalutati nelle donne, patologie tipicamente femminili a lungo trascurate.
L’invisibile che necessita di cura
Oggi la medicina di genere cerca di colmare quel vuoto, ma altre invisibilità resistono: gli anziani, le persone con disabilità, i pazienti pluripatologici. Tutti soggetti reali, centrali nella vita delle comunità, ma spesso assenti dai protocolli di ricerca. Esattamente come le donne del Medioevo: presenti nella realtà, invisibili nella memoria ufficiale.
Rendere visibile è il primo passo per curare davvero
Con il suo intervento al Festival della Mente, Alessandro Barbero ha mostrato come l’invisibilità non sia mai sinonimo di assenza, ma il risultato di una scelta culturale. Nel Medioevo, le donne erano protagoniste della vita quotidiana, della cura, della letteratura e della spiritualità. Sono diventate invisibili perché la memoria scritta ha scelto di oscurarle.
Per le scienze della vita, la lezione è chiara: ciò che non entra nei dati, nei trial, nei registri, rischia di sparire dalla cura. La storia ci ricorda che l’invisibilità è sempre una costruzione. E che rendere visibile è il primo atto di una conoscenza solida, nella storiografia come nella medicina.