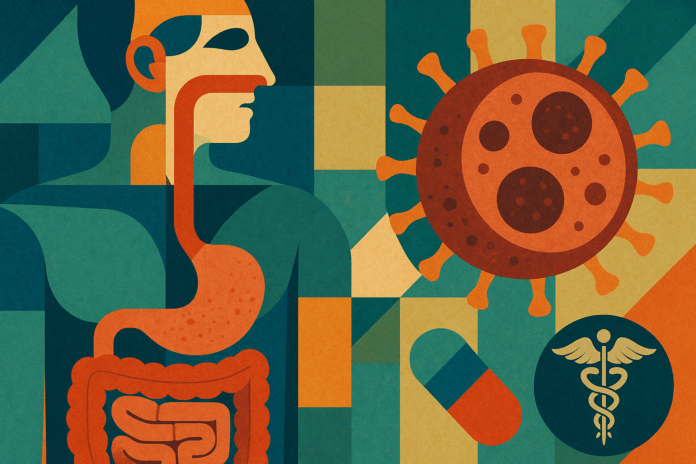“Ricerca e sviluppo di nuovi approcci terapeutici in gastroenterologia: aspetti clinici, farmacologici e sociali“. Così recita il titolo della XIII sessione tematica del Simposio AFI 2025. Un titolo ampio, che riflette la portata trasversale delle patologie dell’apparato digerente, sempre più al centro di un intreccio tra esigenze cliniche non ancora soddisfatte, innovazione farmaceutica e sfide regolatorie complesse.
Dalla fibrosi cistica all’esofagite eosinofila, passando per le IBD e l’Helicobacter pylori, le cronicità gastrointestinali generano un carico terapeutico, economico e psicologico rilevante. Ma sono anche il banco di prova ideale per l’innovazione: qui si sperimentano soluzioni di drug delivery avanzato, biotecnologie mirate e modelli regolatori flessibili.
La 64° edizione del Simposio AFI restituisce uno spaccato aggiornato di queste sfide, attraverso gli interventi di specialisti provenienti dall’industria, dal mondo accademico e dalla clinica.
Terapia enzimatica sostitutiva: un classico da reinventare
L’insufficienza pancreatica esocrina (EPI), condizione frequente nei pazienti con fibrosi cistica o pancreatite cronica, resta uno dei paradigmi della gastroenterologia “farmaceutica”. Qui, la terapia sostitutiva con enzimi pancreatici (PERT) rappresenta un trattamento consolidato, ma tutt’altro che banale.
Lo ricordano Marco Anelli e Massimo Latino (4S4P Medical Affairs): i prodotti oggi disponibili, perlopiù a base di pancrelipasi suina, sono efficaci nel compensare il deficit digestivo, ma presentano criticità nella standardizzazione della produzione, nella biodisponibilità e nell’aderenza terapeutica.
L’attenzione crescente delle autorità regolatorie europee verso la qualità dei PERT – come dimostrato dal caso Micrazym, deferito all’EMA dopo la mancata armonizzazione tra gli Stati membri – riflette un’esigenza più ampia: superare l’inerzia storica del settore per garantire equivalenza terapeutica e sicurezza d’uso, specie nei pazienti pediatrici.
Eosinofili e malattia rara: l’urgenza di riconoscere l’EoE
Tra le “nuove necessità” della gastroenterologia, spicca l’esofagite eosinofila (EoE), una patologia immuno-mediata sempre più diagnosticata, ma ancora sottovalutata.
Lo sottolinea Salvatore Agostino Giammillari (AFI – DMX Pharma), che tratteggia un quadro clinico allarmante: ritardo medio di diagnosi superiore ai sei anni, sintomi sovrapposti alla GERD, impatto devastante sulla qualità della vita e stretta correlazione con comorbidità allergiche (asma, dermatite atopica, riniti, allergie alimentari).
L’EoE si configura oggi come una malattia rara in forte espansione, al punto da rappresentare una “tappa tardiva” della marcia allergica. La patogenesi di tipo 2, dominata da IL-4, IL-5 e IL-13, apre la strada a trattamenti targetizzati, come il dupilumab (anti-IL4Rα), recentemente approvato anche in età pediatrica.
La vera sfida, però, resta la somministrazione locale efficace dei corticosteroidi: i prodotti disponibili – Jorveza (budesonide orodispersibile), Eohilia (budesonide sospensione) ed EsoCap – propongono differenti approcci di rilascio nell’esofago, ciascuno con vantaggi e limiti.
Drug delivery gastrointestinale: la forma conta (più) della sostanza
È proprio il tema del rilascio mirato nel tratto GI a dominare l’intervento di Anastasia Foppoli (Università degli Studi di Milano). A partire da una premessa semplice ma determinante: nei distretti gastrointestinali, l’efficacia di un principio attivo dipende in misura decisiva dalla sua formulazione e dalla capacità di raggiungere – e restare – nel sito bersaglio.
Le strategie sono oggi numerosissime, e disegnano una geografia del rilascio regioselettivo:
-
Esofago: sistemi mucoadesivi, orodispersibili, stent medicati, dispositivi shape memory (come EsoCap o i “flower-like systems”) per aumentare il tempo di contatto.
-
Stomaco: GRDDS (gastro-retentive drug delivery systems) bioadesivi, flottanti, a espansione geometrica (Accordion Pill, LYNX), osmotici (ORODS) o sviluppati tramite 4D printing. Questi permettono una ritenzione prolungata per combattere l’Helicobacter pylori e migliorare la biodisponibilità di molecole assorbite nel tratto prossimale.
-
Colon: sistemi a rilascio pH-dipendente, tempo-dipendente o microbiota-dipendente, fondamentali per le IBD (colite ulcerosa, morbo di Crohn), dove mesalazina e corticosteroidi richiedono precisione di targeting per evitare effetti collaterali sistemici.
Tutti questi approcci si confrontano con limiti pratici: variabilità interindividuale dei parametri fisiologici, bassa predittività del transito, scarsa aderenza, stabilità del principio attivo. Eppure, rappresentano la frontiera più avanzata della formulazione farmaceutica in gastroenterologia.
Dove va la gastroenterologia terapeutica?
Il messaggio conclusivo della XIII sessione del 64° Simposio AFI è chiaro: in gastroenterologia, innovare significa integrare biotecnologia, tecnologia farmaceutica e strategie regolatorie.
Non basta più conoscere la patologia: occorre modellare la terapia sulla fisiologia e sulla vita reale del paziente, affrontando bisogni non ancora riconosciuti (EoE), consolidando trattamenti storici (PERT) e spingendo la formulazione dei farmaci oltre i limiti fisici del tratto gastrointestinale.
Non è solo una questione di molecole, ma di dispositivi, tempi, materiali, comportamenti e – soprattutto – precisione.
La gastroenterologia, oggi, si gioca su millimetri e minuti.