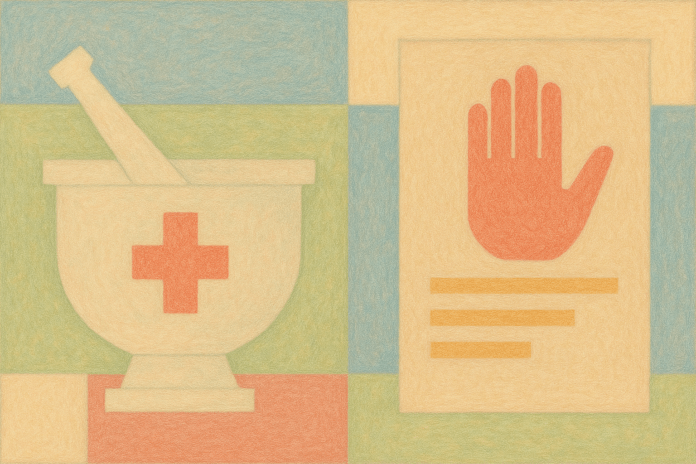Nel cuore delle attività di farmacovigilanza risiede una missione tanto cruciale quanto delicata: garantire che ogni informazione critica sulla sicurezza dei farmaci giunga tempestivamente e in modo comprensibile ai professionisti della salute. È in questo contesto che si inserisce “Rethink Safety Communication: A new way to disseminate aRMM and DHPC“, il progetto promosso da AFI – Associazione Farmaceutici dell’Industria – con il supporto operativo di IQVIA e il sostegno non condizionante di Roche.
L’obiettivo? Ridefinire il modello italiano di comunicazione delle Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) e delle Additional Risk Minimization Measures (aRMM), rendendolo più efficace, coerente e sostenibile.
Il contesto europeo: la cornice normativa e il margine di manovra
Il punto di partenza è il quadro regolatorio europeo: le Good Pharmacovigilance Practices (GVP), in particolare i Moduli XV (Safety Communication) e XVI (Risk Minimization Measures), forniscono indicazioni generali, ma lasciano spazio ai singoli Stati per declinare operativamente le attività. Un’opportunità, questa, che ha generato modelli nazionali eterogenei, spesso più o meno efficaci, più o meno digitalizzati, più o meno sostenibili.
“Rethink Safety Communication” ha analizzato cinque Paesi ritenuti esemplari – Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna – individuando buone pratiche da cui trarre ispirazione per l’Italia.
Il punto di partenza italiano: un modello da aggiornare
In Italia, le DHPC e le aRMM vengono trasmesse con modalità ancora fortemente legate alla carta: nel 2024, le aziende coinvolte nel progetto hanno impiegato circa 8,7 milioni di fogli, pari a 43,6 tonnellate di carta. Ma il problema non è solo ambientale: è anche comunicativo.
Se da un lato esistono buone pratiche (come l’accordo tra titolari AIC per comunicazioni congiunte o l’utilizzo di database certificati per individuare i destinatari), dall’altro permangono criticità che riducono l’efficacia del sistema: materiali difficilmente riconoscibili, assenza di repository centralizzati, mancanza di strumenti digitali integrati nella pratica clinica.
Cosa fanno meglio gli altri? Cinque esempi virtuosi
Il confronto con i modelli europei ha messo in luce soluzioni interessanti:
-
Germania: adotta pittogrammi riconoscibili – la “mano rossa” per le DHPC e la “mano blu” per le aRMM – e integra i materiali nei sistemi IT ospedalieri e farmaceutici.
-
Finlandia: punta tutto sul repository istituzionale, eliminando la necessità di ridistribuzioni cartacee.
-
Francia: utilizza un sistema di invio sequenziale e centralizzato, e coinvolge attivamente le autorità regolatorie.
-
Regno Unito: si affida a un portale privato (Electronic Medicines Compendium), aggiornato in tempo reale e dotato di strumenti analitici.
-
Spagna: delega alle società scientifiche la distribuzione delle comunicazioni, rafforzando la capillarità informativa.
Verso un modello italiano più efficace
Il cuore del progetto è rappresentato da un articolato documento di raccomandazioni, elaborato da un gruppo di lavoro che include titolari AIC, rappresentanti di società scientifiche, farmacisti, pazienti e stakeholder istituzionali. Le proposte operative si articolano in tre macro-aree:
1. Riconoscibilità e comprensione dei materiali
-
Standardizzare graficamente DHPC e aRMM, con l’uso di colori distintivi, pittogrammi ufficiali e loghi istituzionali.
-
Inserire un executive summary chiaro e sintetico all’inizio dei materiali.
-
Indicare sempre la versione e la data di approvazione del documento, con QR code per accedere alla versione aggiornata.
2. Strumenti digitali e repository
-
Creare un repository centralizzato istituzionalizzato, accessibile in tempo reale e integrabile con i sistemi informativi di studi medici, farmacie e ospedali.
-
Prevedere l’accesso differenziato per HCP e pazienti, notifiche automatiche, funzioni di analytics e possibilità di stampa o richiesta copie.
-
Integrare i materiali nei software di prescrizione e dispensazione, con alert contestuali e visibili solo se pertinenti.
3. Formazione e cultura della sicurezza
-
Rafforzare la formazione dei professionisti sanitari sull’importanza dei materiali di safety communication.
-
Introdurre moduli specifici nei corsi universitari di medicina e farmacia.
-
Attivare campagne informative con il coinvolgimento delle società scientifiche e delle associazioni pazienti.
DHPC e aRMM nei programmi di uso compassionevole: un vuoto da colmare
Un’area particolarmente critica emersa nel progetto riguarda i programmi di accesso precoce (uso compassionevole). A differenza dei trial clinici, in cui le informazioni di sicurezza sono dettagliate e regolamentate, qui manca un processo strutturato per fornire aggiornamenti tempestivi e materiali educativi ai clinici e ai pazienti.
Il gruppo propone dunque l’adozione di un iter di approvazione locale, da parte di AIFA, per le attività di minimizzazione del rischio nei programmi di uso compassionevole. Una misura necessaria per assicurare protezione anche in contesti al di fuori della commercializzazione pienamente autorizzata.
Una roadmap per il futuro
Le raccomandazioni del progetto non mirano a rivoluzionare tutto e subito, ma indicano una direzione chiara, con azioni implementabili progressivamente. La chiave è il coinvolgimento di tutti gli attori: aziende, regolatori, clinici, farmacisti, pazienti.
La comunicazione di sicurezza sui farmaci non è solo un obbligo normativo: è un elemento centrale per la fiducia nel sistema, per la protezione del paziente e per l’evoluzione sostenibile della sanità.
Fonte
Rethink Safety Communication: A new way to disseminate aRMM and DHPC (AFI, Roche, IQVIA, 2025)