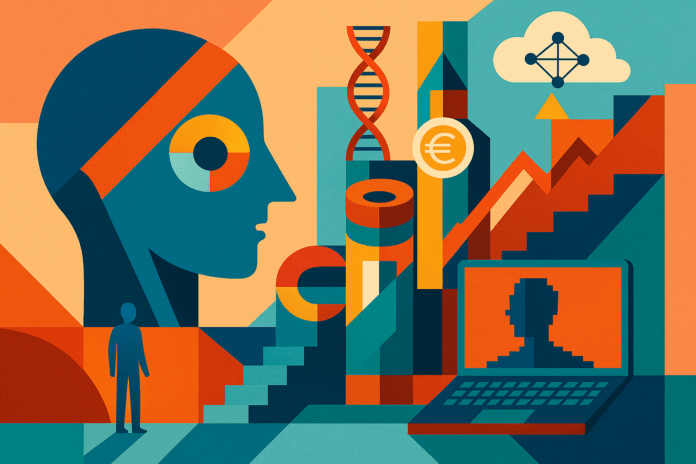Nel cuore della Sessione III del 64° Simposio AFI – significativamente intitolata Digitalizzazione, decentralizzazione, real world evidence: come rendere Italia ed Europa competitive in ricerca clinica – si è delineato il perimetro di una trasformazione radicale. Non più solo un’evoluzione normativa o tecnologica, ma la costruzione di un nuovo ecosistema della fiducia. Fiducia nei dati, nelle piattaforme, negli strumenti digitali. Fiducia nei pazienti, sempre più protagonisti. Fiducia in una Europa capace di parlare con voce unica, senza frammentazioni, per tornare competitiva nello scenario della ricerca clinica globale.
L’Europa che vuole contare: la lezione spagnola
L’intervento di Liana De Plasencia (Evidenze) ha offerto uno sguardo privilegiato sul modello spagnolo: 930 studi clinici autorizzati in un anno, di cui 39% in oncologia e oltre il 22% nelle malattie rare. Una macchina che funziona grazie a interoperabilità tra cartelle cliniche elettroniche, contratti regionali semplificati, sperimentazioni decentralizzate, infermieri di ricerca e piattaforme digitali per il pre-screening dei pazienti. Non è solo una questione di numeri: è una questione di approccio sistemico. La Spagna dimostra che la semplificazione contrattuale, la formazione professionale mirata e l’impiego di tecnologie di patient matching rendono concretamente più attrattivo il Paese per le multinazionali del farmaco. L’Italia, con le sue eccellenze locali, può trarne ispirazione per costruire un sistema più coeso ed efficiente.
Dati reali per decisioni reali
Matteo Della Porta (IRCCS Istituto Clinico Humanitas) ha posto l’accento sul valore strategico della real world evidence (RWE) come leva per superare i limiti degli studi randomizzati tradizionali, soprattutto in ambiti ad alta complessità clinica: malattie rare, oncologia mutazionale, patologie dell’anziano. Le evidenze raccolte al di fuori del contesto sperimentale – da registri, database clinici, cartelle elettroniche – diventano fondamentali non solo per approvare nuovi trattamenti, ma anche per ridefinire il concetto stesso di controllo. E quando i dati reali non sono accessibili, entra in campo il dato sintetico.
Il dato sintetico come ponte tra privacy e scienza
Il futuro della ricerca passa anche per il cosiddetto synthetic data: insiemi di dati artificiali generati da algoritmi di deep learning capaci di riprodurre fedelmente le caratteristiche dei dataset clinici reali. Non essendo legati a soggetti identificabili, questi dati superano i vincoli del GDPR e permettono di armonizzare fonti eterogenee, colmare gap informativi, riequilibrare popolazioni campionarie sbilanciate. Come mostrano gli studi presentati, i dati sintetici offrono performance sovrapponibili ai reali nel contesto delle neoplasie mielodisplastiche, permettendo di ampliare i campioni da poche centinaia a decine di migliaia di pazienti. È un cambio di scala e di paradigma, che impone tuttavia un quadro etico solido, basato su trasparenza degli algoritmi, validazione indipendente e compliance normativa.
Digitalizzazione: più che tecnologia, cultura
Saverio D’Amico, autore di numerosi studi sulla generazione di dati sintetici in ematologia, ha richiamato la necessità di una governance rigorosa e condivisa per l’uso dell’intelligenza artificiale nei trial. Il suo intervento ha evidenziato tre pilastri per l’adozione responsabile di questi strumenti: interpretabilità dei modelli, validazione trasparente e protezione del dato. La digitalizzazione non è solo un upgrade tecnologico: è un cambio culturale, che richiede competenze, consapevolezza, collaborazione tra stakeholder. E in questo processo, le agenzie regolatorie – EMA in primis – stanno già svolgendo un ruolo abilitante attraverso iniziative come la Qualification of Novel Methodologies.
Decentralizzare, per avvicinarsi ai pazienti
Un altro elemento cardine della discussione è stato il decentramento della sperimentazione clinica, oggi sempre più sostenuto da strumenti digitali: eConsent, ePRO, monitoraggio remoto, delivery domiciliare dei farmaci. Come emerso anche dal modello spagnolo, questi strumenti non solo riducono il burden per il paziente, ma aumentano l’aderenza, migliorano la qualità del dato e ampliano l’accesso alla ricerca anche in aree geografiche periferiche o sottorappresentate. È un approccio che mette davvero il paziente al centro, lo informa, lo coinvolge, lo rispetta. E lo trasforma da oggetto di studio a partner attivo del processo scientifico.
Le sfide italiane: un puzzle da comporre
Quali le sfide italiane? La scarsa armonizzazione tra comitati etici, eccessiva durata delle fasi autorizzative, carenza di figure professionali formate, difficoltà nella raccolta sistematica dei dati. Eppure, le opportunità non mancano: l’Italia è tra i paesi europei con la più ampia rete di IRCCS, vanta eccellenze accademiche e ospedaliere, e ha appena approvato una nuova legge sulla sperimentazione clinica che potrebbe snellire molti passaggi burocratici. Serve però una regia nazionale, investimenti mirati, e soprattutto una visione industriale della ricerca come asset strategico per il Paese.
Un’alleanza tra tecnologia, persone e istituzioni
Il messaggio che esce dalla sessione è chiaro: per rendere Europa e Italia competitive nella ricerca clinica serve un’alleanza strategica tra tecnologia, persone e istituzioni. La digitalizzazione non è il fine, ma il mezzo per rafforzare la qualità dei dati, l’efficienza dei processi, la vicinanza al paziente. La decentralizzazione non è solo logistica, ma culturale: rompe i confini tra ospedale e territorio, tra centro e periferia. I dati real-world, se ben raccolti e armonizzati, possono integrare – e talvolta sostituire – gli studi tradizionali, offrendo risposte tempestive in aree a forte unmet need. E i dati sintetici sono già oggi una risorsa concreta per sperimentazioni più rapide, inclusive e rispettose della privacy.
Verso una ricerca clinica europea 5.0
La vera sfida non è solo recuperare competitività, ma guidare l’innovazione. L’Europa ha tutte le carte per definire un nuovo modello di ricerca clinica: più sostenibile, più equa, più intelligente. Ma occorre un cambio di passo, che parta dalla formazione, passi per la collaborazione pubblico-privato, e arrivi a una politica industriale della scienza che sappia fare sistema. Perché la ricerca clinica non è solo un ambito tecnico: è la cartina di tornasole di una società che sceglie, con coraggio, di investire nel proprio futuro.