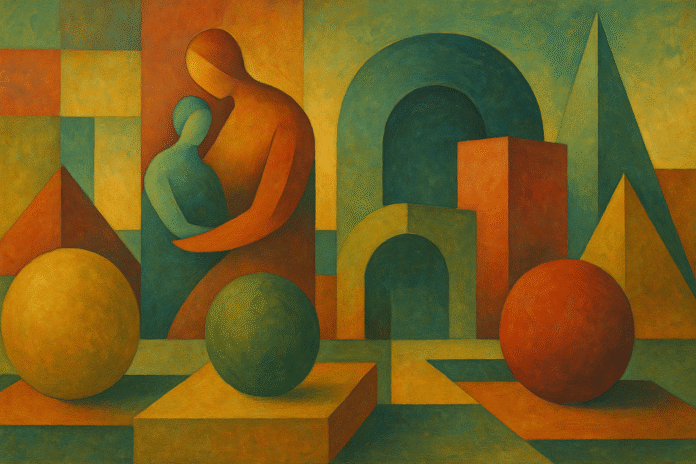In Italia più di sette milioni di persone si prendono cura ogni giorno di un familiare fragile, disabile o non autosufficiente. Lo fanno spesso in silenzio, nel privato delle case, supplendo alle carenze di un sistema di assistenza che ancora fatica a reggere l’urto dell’invecchiamento demografico e della crescita delle cronicità. Sono i caregiver familiari: una figura chiave per la tenuta sociale del Paese, ma ancora in cerca di un riconoscimento pieno e stabile.
Chi sono i caregiver e perché contano
Il caregiver familiare, secondo la definizione introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), è la persona che assiste in modo continuativo un parente o affine non autosufficiente per effetto di malattia o disabilità. Dietro questa formula burocratica si nasconde una realtà complessa, fatta di tempo, energia e competenze che spesso non vengono riconosciute né economicamente né giuridicamente. Si stima che i caregiver siano per il 70% donne tra i 45 e i 64 anni, che in molti casi riducono o abbandonano il lavoro per dedicarsi alla cura, con un impatto diretto sul reddito familiare e sulla salute psicofisica.
Il contributo che queste persone danno al Paese è enorme: secondo alcune stime, il valore economico del lavoro di cura informale equivale a circa il 3 % del PIL. Ma il loro ruolo rimane privo di una cornice normativa organica.
Quadro normativo: riconoscimenti e limiti
La figura del caregiver è stata riconosciuta a livello statale con la legge n. 205/2017, che istituì anche un Fondo per il sostegno del caregiver familiare. Tuttavia, la normativa non ha mai trovato piena attuazione, e il quadro è oggi un mosaico frammentato di misure regionali. L’Emilia-Romagna è stata la prima Regione a dotarsi di una legge dedicata nel 2014 (“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”), ma il risultato è un’Italia a più velocità: alcune Regioni offrono contributi economici, formazione o servizi di sollievo; altre non prevedono alcun sostegno strutturato.
A livello nazionale, i caregiver possono accedere a permessi e congedi previsti dalla legge 104/1992 per chi assiste un familiare con disabilità grave. Ma si tratta di strumenti pensati per chi assiste familiari con disabilità riconosciuta, non per l’insieme di chi si fa carico di persone non autosufficienti. Mancano tutele previdenziali, percorsi formativi, supporto psicologico e incentivi fiscali. Mancano, soprattutto, criteri uniformi: non esiste una definizione condivisa di “non autosufficienza” né un sistema per misurare la quantità di tempo dedicato alla cura.
La fotografia attuale è dunque quella di un sistema diseguale, dove il destino del caregiver dipende più dal CAP di residenza che dalla gravità della situazione familiare. Non stupisce che le principali associazioni, come Cittadinanzattiva e CARER – Associazione Nazionale Caregiver Familiari, abbiano parlato di «promesse tradite».
Lo stato dell’arte: numeri, dinamiche e contesto
Le ultime rilevazioni evidenziano che in Italia i caregiver familiari sono stimati in circa 7-8 milioni. Di questi, circa 4 milioni assistono persone non autosufficienti o con disabilità cronica. Il 60-75% circa dei caregiver sono donne, spesso in età tra 45 e 64 anni. Il tema assume una rilevanza crescente in un contesto di “invecchiamento della popolazione”, aumento delle cronicità e forte pressione sul sistema di assistenza domiciliare.
Dal punto di vista pratico, il lavoro di cura informale comporta forte impegno orario, stress psicofisico, perdita di reddito da lavoro, ricorso limitato ai servizi pubblici (o sovraccarico dei servizi stessi). Eppure, la visibilità istituzionale resta relativamente bassa. Al contempo, l’esperienza della pandemia e la pressione sugli ospedali hanno evidenziato l’importanza della cura a domicilio e del supporto informale.
Prospettive e riforme in corso
La recente legge 33/2023 sulla non autosufficienza ha previsto, tra gli obiettivi, il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare. Tuttavia, l’attuazione operativa della riforma appare ancora incompleta: mancano decreti attuativi pienamente efficaci, e restano dubbi sugli strumenti e sulla platea. Il percorso normativo attende ancora il via libera formale di un disegno di legge statale — ad esempio il DDL S.24 “Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”.
Nel Documento Programmatico di Bilancio 2026-2028 (DPB) inviato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze vengono indicate risorse specifiche per il completamento della riforma: tra queste un fondo da 1,15 milioni di euro per il 2026 e di 207 milioni annui a decorrere dal 2027 destinato al sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Tuttavia, le associazioni rilevano che si tratta di cifre ancora troppo modeste rispetto alle necessità e che senza una legge nazionale il fondo rischia di restare una voce di bilancio più simbolica che risolutiva.
Guardando al futuro, la sfida non è soltanto normativa ma culturale. L’Italia, più di altri Paesi europei, continua a considerare la cura familiare come un dovere privato, quasi invisibile. Nei sistemi nordici, invece, il caregiver è riconosciuto come figura di raccordo tra paziente, medico e servizi, viene formato e retribuito in modo adeguato. In questo senso, il ritardo italiano non è solo una questione di fondi ma di mentalità: la cura viene ancora delegata alla famiglia, in un modello di welfare “invisibile” che si regge su dedizione e sacrificio.
Impatto sull’industria farmaceutica
Per l’industria farmaceutica l’esperienza del caregiver rappresenta un nodo strategico per la gestione delle terapie a lungo termine, in particolare in ambito cronico e oncologico. Il caregiver è spesso la persona che garantisce l’aderenza terapeutica, la somministrazione corretta dei farmaci, la gestione delle visite e dei controlli. In altre parole, il caregiver è il primo alleato — o talvolta il primo ostacolo — dell’efficacia terapeutica.
Per le aziende farmaceutiche questo significa ripensare i propri modelli di relazione. Non basta più progettare farmaci sicuri ed efficaci: occorre renderli “caregiver-friendly“. La semplificazione dei packaging, la chiarezza delle istruzioni, la disponibilità di soluzioni di somministrazione a domicilio, e strumenti digitali di supporto diventano fattori che incidono direttamente sul successo terapeutico e sulla soddisfazione del paziente. La logica “patient-centric” evolve in una visione più ampia, “care network-centric”, dove il caregiver è un interlocutore a pieno titolo.
In parallelo, la crescente centralità dell’assistenza domiciliare apre spazi di innovazione che coinvolgono direttamente l’industria: sistemi di monitoraggio remoto, terapie auto-iniettabili, programmi di educazione digitale e di supporto psicologico condivisi tra aziende, istituzioni e associazioni di caregiver. Anche la farmaceutica, in questo senso, può contribuire a creare valore sociale oltre che sanitario.
Naturalmente, esistono rischi. Il riconoscimento formale del caregiver come figura di supporto sanitario potrebbe comportare nuove responsabilità in termini di formazione, sicurezza e corretto uso dei farmaci. Le aziende dovranno muoversi con cautela, evitando di trasferire sulle famiglie compiti che restano di competenza medica. Tuttavia, il dialogo tra industria e caregiver può diventare un laboratorio di innovazione e di empatia: un terreno su cui costruire nuove forme di fiducia tra chi produce terapie e chi, ogni giorno, le rende possibili nel concreto della vita quotidiana.
Verso un nuovo paradigma della cura
Il destino del caregiver familiare non riguarda soltanto il welfare. Riguarda la sostenibilità stessa del sistema sanitario, la capacità del Paese di affrontare la transizione demografica e, in ultima analisi, l’evoluzione della cultura della cura. L’industria farmaceutica può e deve essere parte di questa evoluzione: non solo osservatore, ma protagonista responsabile. Finché le politiche pubbliche non offriranno risposte concrete, saranno proprio i caregiver — e chi li sostiene, dentro e fuori le istituzioni — a reggere il peso più grande del nostro futuro di cura.