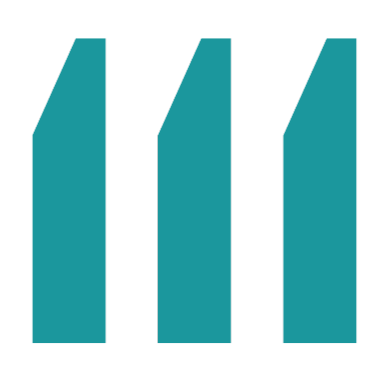Sebbene comunità scientifica, istituzioni e autorità regolatorie internazionali continuino a ribadire l’importanza di un approccio clinico che tenga conto delle differenze fisiologiche e sociali tra i sessi, la medicina genere-specifica fatica ad affermarsi e persiste un chiaro divario nella prevenzione, nell’insorgenza, nei trattamenti e negli esiti delle malattie.
“Vi è una scarsità di ricerca incentrata sui fattori razziali-etnici, socio-economici, psicosociali e ambientali che perpetuano le disparità” afferma un recente articolo pubblicato sulla rivista scientifica Cells. Questi fattori multidimensionali interagiscono tra loro e possono influenzare la risposta farmacologica. Si tratta di differenze che coinvolgono sia aspetti biologici e fisiologici che psicologici e sociali e non riguardano solo la differenza tra i sessi.
«Partiamo da un chiarimento, evidenziato anche dalla definizione che ne dà l’Organizzazione mondiale della sanità – spiega Silvia De Francia, ricercatrice in farmacologia all’Università di Torino e autrice del libro “La medicina delle differenze: Storie di donne uomini e discriminazioni”. – La medicina di genere, o meglio genere-specifica, non è una branca specialistica della medicina. È, invece, un diverso approccio che in tutte le discipline mediche tiene conto dell’influenza del sesso e del genere sullo stato di salute e di malattia di ciascun individuo. Questo concetto si applica naturalmente anche alla farmacologia, che rientra nel novero delle specialità mediche. Anche la farmacologia genere-specifica, dunque, considera l’accezione biologica – il sesso – e quella sociale – il genere – nel paradigma di cura».

Iniziamo dalla biologia: dal punto di vista farmacologico che differenze osserviamo?
Il movimento dei farmaci all’interno del corpo segue un percorso in quattro tappe definito Adme: assorbimento, distribuzione, met
abolismo ed eliminazione.
Chiaramente le differenze tra un corpo biologicamente maschile e uno biologicamente femminile ci sono e devono essere tenute nella giusta considerazione.
Spesso le discipline sociali tendono a eliminare le differenze ma dal punto di vista della farmacocinetica le differenze sono fondamentali perché il corpo maschile e il corpo femminile sono costituiti da componenti differenti che influiscono su tutte le tappe del percorso dei farmaci. Il diverso spessore e la differente componente acquosa dello strato cutaneo nei due sessi, ad esempio, determina diversi profili di assorbimento per la stessa molecola.
A livello di distribuzione, le proteine carrier – albumina e glicoproteine – che trasportano i farmaci all’interno del corpo vengono espresse in modo diverso da uomini e donne.
Anche la fase metabolica presenta due panorami profondamente differenti perché diversa è l’espressione genetica dei citocromi, i com
plessi multienzimatici che agiscono a livello epatico per metabolizzare i farmaci. Questo fa sì che la stessa molecola subisca un metabolismo differente in donne e uomini, come avviene, ad esempio, per la maggior parte dei farmaci impiegati in ambito cardiovascolare.
L’eliminazione è un altro punto dolente: la donna possiede una minore capacità di filtrazione renale e ciò si traduce in tempi di eliminazione più lunghi e, quindi, in mantenimento di concentrazioni circolanti spesso più elevate. La conseguenza diretta, naturalmente, è una maggiore frequenza di eventi di tossicità. Non a caso le reazioni avverse da farmaco si riscontrano principalmente nella popolazione femminile.
Su tutto questo pesa ovviamente anche la caren
za di conoscenze relative alla risposta ai farmaci nel modello femminile, visto che gran parte delle sperimentazioni sono finora state effettuate principalmente sul modello maschile.
Ora l’accezione sociale: in cosa differiscono sesso e genere?
Il sesso è una caratteristica biologica, frutto della componente genetica che, fin dalla nascita, influenza la nostra risposta ai trattamenti farmacologici o la predisposizione allo sviluppo di malattie. In questo senso il nostro patrimonio genetico, caratterizzato da milioni di mutazioni diverse a livello interindividuale, ci differenzia in termini di salute, malattia e risposta alle terapie.
Il genere, invece, è un costrutto molto più ampio, un’accezione che comprende una moltitudine di variabili che rientrano nella sfera socio-economica e culturale, connotando i fattori di rischio di ciascuno in modo assolutamente peculiare: le abitudini di vita, le malattie concomitanti, il fumo, il livello di attività fisica ecc.
Non in tutti casi, comunque, questi fattori sono frutto di una libera scelta.
Nascere, ad esempio, in una grande città in un Paese avanzato rappresenta un evidente vantaggio per l’accesso alle cure rispetto a vivere in una zona meno fortunata del mondo, con il primo ospedale a 500 chilometri di
distanza.
In che senso si parla di medicina “genere-specifica” e non di medicina “di genere”?
La medicina genere-specifica è un ap
proccio che mira a curare ciascun individuo secondo le sue singolarità, sia esso uomo, donna o transgender. Quest’ultimo caso è particolarmente emblematico perché mostra con chiarezza l’essenza del problema: un organismo in trasformazione, complesso, con un sistema ormonale misto, con componenti sia androgeniche sia estrogeniche. In questo contesto l’evoluzione delle malattie – ma anche le interazioni dei farmaci con l’organismo – diventa imprevedibile perché non studiata. Ciononos
tante al momento non sono previsti studi ad hoc per questi pazienti.
Questo approccio tende alla medicina di personalizzazione: possiamo immaginarci una medicina per ceto sociale, area geografica o abitudini alimentari?
È quello che mi piacerebbe avvenisse in un futuro, possibilmente non troppo remoto.
Ciascuno di noi è diverso per come risponde alle cure e il fattore socio-economico incide pesantemente: in certe zone del mondo può curarsi solo chi può permetterselo; non dimentichiamo che negli Stati Uniti, ad esempio, un test per il Covid-19 è arrivato a costare oltre 100 dollari. Un editoriale di Lancet pubblicato un anno e mezzo fa descrive la diffusione del coronavirus non come “pandemia” ma come “sindemia”, un termine che indica proprio l’intreccio sinergico tra problemi di salute, ambientali, sociali ed economici.
Cosa ostacola lo sviluppo di farmaci mirati alla popolazione femminile, che sarebbero più efficaci e quindi potenzialmente più competitivi per le aziende farmaceutiche?
Per i farmaci presenti sul mercato già da decenni non vi è alcun interesse delle case farmaceutiche a rifare completamente gli studi, riscrivere le linee guida, rimettere in discussione prodotti già affermati. Quasi nessuno, che io sappia, ha rivisto le indicazioni di farmaci datati come gli antipertensivi o le statine, poco efficaci, a volte, i primi, assolutamente tossiche, le seconde, per le donne. Per quanto riguarda i farmaci nuovi, c’è una duplice ragione.
Innanzi tutto, come abbiamo visto nella recente sperimentazione per alcuni vaccini anti-Covid, su scala mondiale è più facile reperire volontari sani di sesso maschile. In secondo luogo, la sperimentazione clinica sul corpo femminile è necessariamente più elaborata e costosa.
A differenza dell’uomo, che dal punto di vista ormonale resta sostanzialmente identico per 60-70 anni, l’organismo femminile presenta una situazione più articolata con moltissime variabili che entrano in gioco nel periodo di vita fertile, la gravidanza, l’allattamento, la contraccezione ormonale, la menopausa, nonché naturalmente le variazioni periodiche dovute al ciclo mestruale.
Sono tutte situazioni che andrebbero investigate separatamente; quindi, per condurre studi clinici che coinvolgano il campione femminile in modo adeguato sarebbe necessario un numero molto superiore rispetto a quello utile per un trial tradizionale focalizzato sugli uomini. La situazione è anche peggiore nel caso della sperimentazione pre-clinica perché al momento non ci sono normative che obblighino i ricercatori pubblici o privati a testare le molecole su cavie femminili o linee cellulari provenienti da organi di donatrici.
Dato quanto detto finora, e considerato che i fondi sono limitati, i ricercatori pubblici continuano a preferire studi impostati su un numero contenuto di animali maschi, che costano meno e sono più semplici da gestire dal punto di vista sperimentale.
I dati sono spesso disponibili ma trascurati; in uno studio a cui lei ha collaborato avete messo in evidenza una differenza importante negli effetti collaterali della chemioterapia, senza necessità di nuovi esperimenti.
Sì, noi abbiamo effettuato una semplice revisione delle cartelle cliniche per il Centro Oncoematologico Subalpino di Torino su pazienti con diagnosi di carcinoma al colon retto e di carcinoma al pancreas. Ci siamo resi conto che le donne, per poter sopportare la chemioterapia e avere una qualità di vita accettabile devono assumere molti più farmaci concomitanti. Del resto gli antineoplastici che ancora oggi vengono somministrati sono per lo più farmaci di vecchia generazione, molto robusti ma con un potere distruttivo enorme. Sono stati principalmente testati su individui di sesso maschile e quindi, sebbene gli effetti collaterali sulle donne siano gli stessi riportati per l’uomo, nella popolazione femminile si verificano più frequentemente.
Quindi anche studi non sperimentali come quello sul pancreas confermano la necessità di considerare i malati individualmente. Dobbiamo garantire a tutti il diritto a cure che consentano una qualità di vita dignitosa.
Com’è la situazione in Italia dopo la legge 3 del 2018?
A giugno 2019, la legge 3 dell’11 gennaio 2018 si è trasformata in piano attuativo per la diffusione e applicazione della medicina di genere all’interno del Sistema sanitario nazionale con, inoltre, l’istituzione di un osservatorio dell’Istituto superiore di sanità atto al monitoraggio del lavoro delle Regioni.
Si tratta di una legge molto ben strutturata e, se fosse seguita, sarebbe ampiamente sufficiente a recuperare il gap esistente. Consta di quattro punti cardine, che prevedono l’applicazione della medicina di genere nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nella ricerca, nella formazione, nell’aggiornamento professionale e anche a livello mediatico per coinvolgere il grande pubblico.
Purtroppo, solo poche Regioni finora si sono attivate in tal senso: tra queste, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. In Piemonte, come anche in altre Regioni, è stato recentemente istituito, in recepimento della normativa vigente, un tavolo per la medicina di genere, con un gruppo tecnico di lavoro di cui anch’io faccio parte. In moltissime altre Regioni, però, la legge non è ancora stata neanche recepita.
Su questo processo, il Covid ha avuto un doppio effetto: da un lato ha rallentato il processo di applicazione della legge, dall’altro ha contribuito a diffondere una maggior conoscenza del concetto di medicina di genere nella popolazione, grazie al differente impatto che il coronavirus ha avuto su uomini e donne.
Non le chiedo che aspettative ha sul nuovo governo ma cosa chiederebbe alla prima prima ministra in Italia se ne avesse la possibilità?
L’aspettativa ideale sarebbe che il nuovo governo continuasse il lavoro iniziato dalla ministra Beatrice Lorenzin e continuato dalla ministra Giulia Grillo che – con coraggio – hanno dato vita e siglato una legge in cui finalmente si considera il genere da tutti i punti di vista e si afferma l’importanza dell’identità di genere: una visione in cui contano gli omosessuali, i transgender, gli emarginati, le famiglie costituite da due genitori dello stesso sesso. Una medicina che curi ciascun individuo per come è fatto, senza discriminazioni, perché è fondamentale che il nostro Servizio sanitario nazionale continui a essere democratico e universale.