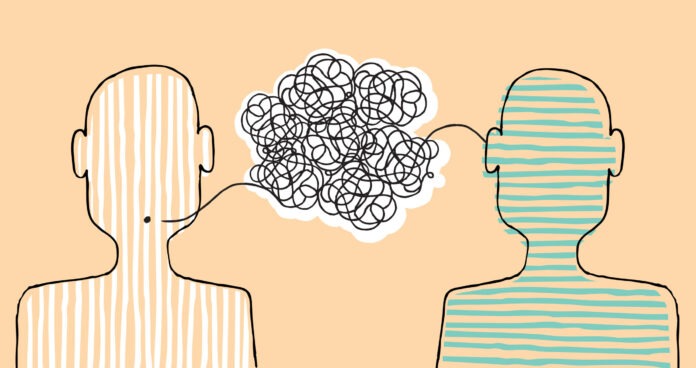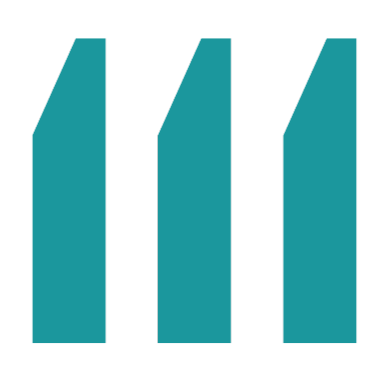La comunicazione al paziente della malattia non è una questione banale, né è rimasta invariata nei secoli. Nelle parole è insito infatti un potenziale effetto iatrogeno che si somma a quello generato dall’insieme dei trattamenti cui si sottopone il paziente. Un’azione che molti hanno cercato di quantificare e che qualcuno è riuscito a raccontare con delicata empatia. Così è accaduto al neurologo Fabrizio Benedetti, che ha studiato gli effetti farmacologici scatenati dall’interazione con pazienti affetti da patologie gravi.
In generale, le fasi della terapia nelle quali le parole sembrano assumere un valore strategico sono quelle della prescrizione di nuovi trattamenti, della spiegazione di cosa sia un consenso informato, della presentazione di una diagnosi che non dissolve i dubbi, e della preparazione dei pazienti a procedure dolorose o invasive.
La malattia al centro
Temuta nell’approccio al consulto medico, indagata durante l’anamnesi, esplorata in fase diagnostica, aggredita con le terapie. La malattia ha inevitabilmente rappresentato per secoli il soggetto principale dell’interazione medico-paziente.
Dapprima nel tentativo di formulare una diagnosi, poi nella stesura del piano di terapia e ancora nel follow up è stato storicamente più immediato concentrarsi sui sintomi, sulla loro scomparsa o esacerbazione, piuttosto che sul paziente come elemento di unicità.
Il successo di questo approccio, che si presta all’oggettivizzazione e alla standardizzazione galileiana, è legittimato dalla piena compatibilità con il metodo scientifico. Ma scricchiola sotto i pesanti passi dell’innovazione, che procedono speditamente verso un mondo che ha superato la logica binaria, ha abbandonato la cara, vecchia questione di vita o di morte, per concedersi all’ambiguità delle zone grigie, a concetti facilmente sfuggenti – come la qualità di vita – diventate nel frattempo un nuovo habitat delle scienze mediche.
Il medico confronta, il paziente assolutizza
Com’è noto, per effetto dell’amplificazione viscerosomatica, la stessa noxa patogena può produrre infinite sfumature di uno stesso sintomo, diversi gradi di sofferenza e lasciare un ricordo del tutto soggettivo. Il tutto in funzione della sensibilità personale e delle circostanze fisiche, psicologiche ed emotive nelle quali si trova il paziente.
Nell’interazione, tuttavia, il medico di base, lo specialista, il referente per la sperimentazione clinica, e il farmacista hanno bisogno di riferimenti precisi. Il paziente si sente legittimamente al centro del suo palcoscenico, all’interno di una scena dalla quale peraltro avrebbe preferito tenersi fuori. L’operatore sanitario tende invece a riportare il singolo caso a una categoria più generale e da lui più agevolmente leggibile.
Ed è nel tentativo di attribuire un valore al sintomo, fedele indice dell’effettivo quadro clinico, che il professionista incastona nel racconto arzigogolato e apparentemente confuso del paziente interruzioni e puntualizzazioni, comportamenti di cut off che hanno lo scopo di riportare lo scambio a un piano di maggiore oggettività.
Verso un nuovo modello
Il fallimento del modello disease centered ha aperto molti dibattiti sulle possibili evoluzioni della comunicazione al paziente.
La volontà di estendere il campo di osservazione dell’operatore sanitario, di leggere il disturbo come una complessità personale e sociale ha portato alla nascita del paradigma biopsicosociale. Secondo quest’ultimo, la comprensione della malattia può realizzarsi solo attraverso lo studio degli aspetti biologici, psicologici e sociali in cui si sviluppa nei singoli pazienti. Un approccio lodevole, ma dispersivo.
D’altronde, se il coinvolgimento del paziente sembra essere un punto irrinunciabile, non è stato sempre chiaro su quali leve agire per generare engagement.
Informare il paziente fin nei minimi particolari, metterlo al corrente di tutti i risvolti della sua malattia, descrivere minuziosamente le terapie prescritte: potrebbe essere una strategia efficace? Forse in un mondo ideale. Nella realtà si è osservato che conoscere tutte le reazioni avverse dei farmaci assunti aumenta la frequenza con cui questi vengono avvertiti e riportati.
La stessa esistenza dell’effetto nocebo è testimonianza di questo importante aspetto, la cui gestione pone più di qualche interrogativo etico. Oggi, l’evoluzione delle tecnologie biomediche permette la rilevazione di dettagli sempre più sofisticati. Ci si domanda ora quale reale contributo possa offrire alla terapia la comunicazione al paziente di dati privi di valore diagnostico.
Comunicare il rischio
È tuttavia non solo opinione diffusa ma legge che il paziente debba essere a conoscenza del rischio connesso a un trattamento o a una procedura, inteso come probabilità che a seguito di essi si verifichi un danno o una lesione. Si tratta di un fenomeno che oggi stiamo vivendo in maniera amplificata. La diffusione di dati di farmacovigilanza sul vaccino AstraZeneca non accompagnati da adeguata comunicazione dei meccanismi con cui questa scienza si muove ha generato comprensibile e prevedibile allarme nella popolazione. Ha così messo a rischio l’engagement del pubblico nella campagna vaccinale.
Piuttosto che chiedersi se informare il paziente, sarebbe piuttosto opportuno domandarsi come farlo. La strutturazione del messaggio influenza infatti la sua percezione delle informazioni e quindi i comportamenti finali. E tenere conto del livello di alfabetizzazione sanitaria della popolazione cui l’informazione è destinata.
Inoltre, poiché la comunicazione è un processo biunivoco, è assolutamente necessario che il paziente vi partecipi con ruoli attivi di primaria importanza. Come può farlo? Ad esempio:
- riportando la propria esperienza personale con i farmaci;
- fornendo il proprio parere sulla comprensibilità e la pertinenza dei messaggi prodotti;
- partecipando all’elaborazione dei documenti diretti al pubblico, come i foglietti illustrativi e le comunicazioni in materia di sicurezza;
- supportando i media con elementi di storytelling della malattia.
Ciò che il paziente porta con sé
Per arrivare a una descrizione completa della malattia, si è quindi giunti alla conclusione che sia necessario andare oltre il mero elenco dei sintomi. Bisogna includere invece l’insieme di idee, sentimenti, aspettative e contesto che accompagnano il paziente e ne costituiscono la cosiddetta “agenda”.
Nell’ambito della consultazione clinica, la comunicazione deve permettere di abbracciare queste quattro dimensioni che il paziente porta con sé e con la sua malattia.
Il professionista raccoglie informazioni finalizzate alla costruzione di un quadro dettagliato. Generalmente si usa una strategia open-to-close nella quale a domande aperte, necessarie a mettere a fuoco la circostanza in maniera più grossolana, seguono approfondimenti puntuali di completamento. In questa fase la capacità di ascolto dell’operatore e la sua abilità nell’utilizzo delle tecniche di continuazione mettono il paziente nella condizione di riportare il suo vissuto di malattia senza essere inibito da interruzioni e chiarimenti.
È nella seconda fase dello scambio che il paziente vede restituite informazioni circa il suo stato di salute. Ed è qui che, al fine di generare engagement e favorire l’aderenza alla terapia, la comunicazione richiede chiarezza espositiva e abolizione di inutili e fuorvianti tecnicismi.
Infine, al di là delle circostanze estemporanee, occorre costruire una relazione con il paziente. Sarà così possibile oltrepassare il concetto dello scambio di informazioni, seppure rilevanti, per sconfinare in un territorio nel quale tecniche e strategie possono ben poco e ci si deve affidare alla potenza del dialogo. Perché la relazione evolve nel tempo, intensificandosi nei momenti di riacutizzazione della malattia e rispondendo, per quanto consentito dalle conoscenze, alle preoccupazioni vere del paziente e non al bisogno di adempiere al commitment della completezza scientifica.