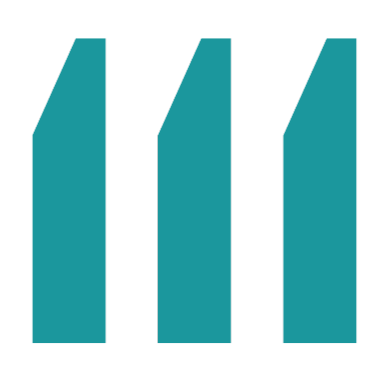Lo sviluppo di un farmaco, si sa, costa miliardi di dollari e anni di lavoro. Garantire la sostenibilità economica durante tutte le fasi è impresa ardua, che richiede il ricorso a molteplici meccanismi di finanziamento e il coinvolgimento di numerosi partner, peraltro differenti a seconda delle fasi di sviluppo. Tipicamente, la ricerca di base viene finanziata da fondi statali o da organizzazioni no-profit, mentre lo sviluppo in fase avanzata è sostenuto dalle aziende farmaceutiche o dai venture capitalist. Anche la biotech Genenta ha seguito questo percorso, salvo poi concedersi un salto di qualità eccezionale.
Nata nel 2014 come spin-off dell’ospedale San Raffaele (OSR) di Milano dall’iniziativa di Pierluigi Paracchi (un venture capital), del prof. Luigi Naldini (direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica) e di Bernhard Gentner (a capo dell’Unità traslazionale cellule staminali e leucemia dell’OSR) ha inizialmente raccolto i capitali necessari attraverso ripetuti round di finanziamento con istituzioni finanziarie e numerose realtà dell’imprenditoria italiana.
 A dicembre 2021, il cambio di passo: Genenta viene quotata al Nasdaq e diventa la prima company italiana in assoluto a sbarcare sul listino tecnologico americano. L’IPO (l’offerta pubblica iniziale) è un successo, con una domanda pari al doppio dell’offerta. La storica quotazione non è scevra da complicazioni o rischi ma offre anche opportunità uniche, come racconta in questa intervista Pierluigi Paracchi, co-founder e Ceo della società. «Per noi sarebbe stato decisamente più facile quotarci in Italia o in Europa perché sia l’ospedale San Raffaele di Milano sia Luigi Naldini – sia molti dei leading investor – seppur conosciuti all’estero, sono sicuramente molto più noti nel nostro Paese. Tra l’altro Borsa italiana ora è in Euronext, quindi saremmo comunque stati presenti su un mercato di respiro europeo. La verità, però, è che il mercato dei capitali di gran lunga più competente al mondo resta quello americano, per ora».
A dicembre 2021, il cambio di passo: Genenta viene quotata al Nasdaq e diventa la prima company italiana in assoluto a sbarcare sul listino tecnologico americano. L’IPO (l’offerta pubblica iniziale) è un successo, con una domanda pari al doppio dell’offerta. La storica quotazione non è scevra da complicazioni o rischi ma offre anche opportunità uniche, come racconta in questa intervista Pierluigi Paracchi, co-founder e Ceo della società. «Per noi sarebbe stato decisamente più facile quotarci in Italia o in Europa perché sia l’ospedale San Raffaele di Milano sia Luigi Naldini – sia molti dei leading investor – seppur conosciuti all’estero, sono sicuramente molto più noti nel nostro Paese. Tra l’altro Borsa italiana ora è in Euronext, quindi saremmo comunque stati presenti su un mercato di respiro europeo. La verità, però, è che il mercato dei capitali di gran lunga più competente al mondo resta quello americano, per ora».
Cosa intende per mercato competente?
Significa che la cultura finanziaria, la propensione al rischio e la capacità di investimento sono decisamente superiori rispetto a quelle degli altri mercati al momento. Il numero di investitori, banche e analisti è straordinariamente maggiore e questo comporta non solo più disponibilità di capitali ma anche una migliore capacità degli investitori di comprendere e apprezzare la ricerca biotecnologica. Attraversare l’Atlantico ha comportato un percorso più complesso – a maggior competenza corrisponde anche maggior competizione – ma crediamo fortemente nel valore della nostra terapia e siamo convinti di essere nel mercato corretto, dove peraltro sono quotati tutti i nostri competitor. Scegliendo altre geografie avremmo avuto un accesso facilitato ma con il rischio di difficoltà maggiori nel prosieguo del cammino.
Che vantaggi offre essere quotati al Nasdaq, al di là dell’accesso al capitale?
Lo standard della SEC (Securities and exchange commission è l’ente americano di vigilanza della Borsa NdR) è estremamente elevato, la procedura di avvicinamento molto complessa soprattutto se non sei americano, però la “certificazione” implicita nell’essere quotati al Nasdaq permette un’interlocuzione con le grandi realtà del settore – pharma e biotech – che sarebbe altrimenti più difficile. I reali competitor del Nasdaq che stavano emergendo prima della pandemia erano Hong Kong e lo Star market Shanghai (il Nasdaq cinese NdR). L’Europa da questo punto di vista, seppur in crescita, ha tipicamente investitori con minore propensione al rischio, oltre ad essere meno per numero.
Però per un mercato così competente occorre essere adeguatamente preparati. Come vi siete organizzati per sbarcare al Nasdaq?
Uno degli elementi chiave che secondo me ci fa onore è proprio che siamo una legal entity italiana, una SpA con attività di ricerca in Italia ma siamo riusciti ad attirare competenze statunitensi di primissimo livello: il nostro nuovo chairman vive in North Carolina, il chef medical officer in New Jersey, così come il business developer, il chef financial officer a San Diego, in California. Abbiamo attirato executive da big pharma, come GlaxoSmithKline e Astra Zeneca, da università e da società quotate.
Questo è stato possibile grazie alla combinazione di due elementi. Da un lato, il livello scientifico della nostra proposta che è straordinario: noi abbiamo trasferito in ambito oncologico una piattaforma per le malattie rare che, non dimentichiamoci, ha prodotto la prima terapia genica al mondo ex vivo approvata per la commercializzazione. Questo ci fornisce un vantaggio competitivo enorme. Il secondo fattore è culturale: in America credono davvero che tutto sia possibile, hanno una fortissima propensione a cercare soluzioni innovative seguendo strade sconosciute, quindi anche talenti affermati sono più propensi a vedere in una company italiana la possibilità che un domani diventi la next big biotech company.
Come cambia la filiera produttiva con le terapie avanzate rispetto ai tradizionali prodotti farmaceutici di mass market?
Si tratta di un punto chiave che è destinato a rivoluzionare l’intero sistema della sanità. Queste terapie hanno potenzialità terapeutiche enormi, come hanno ampiamente dimostrato le Car-T nei tumori del sangue, ma la loro gestione e somministrazione è molto più complessa e sensibilmente differente rispetto alle piccole molecole o ai vaccini. Un aspetto critico riguarda la distribuzione dei costi. Le terapie avanzate prevedono un unico trattamento, “one shot”, il cui costo è dunque concentrato – almeno teoricamente – in un’unica soluzione e non è distribuito in un periodo prolungato di mesi o anni come avviene per molte terapie oncologiche tradizionali.
Questo comporta un impegno di spesa oneroso per i sistemi sanitari che diventa problematico nel momento in cui queste terapie si diffondono. Una soluzione proposta è il principio del pay per performance, che lega il completo pagamento del trattamento alla sua efficacia nel tempo: se il paziente ottiene i benefici attesi e li mantiene nell’arco di mesi o anni il pagamento avverrà in modo concorde, altrimenti sarà interrotto. Questo è solo uno dei modi che si stanno studiando, non necessariamente il migliore, in attesa naturalmente che i costi con il tempo si riducano, come è avvenuto per ogni rivoluzione tecnologica.
Voi come avete risentito dell’impatto degli eventi geopolitici legati alla fase pandemica?
L’arrivo della pandemia ha avuto impatto nullo, se non addirittura positivo, sulle relazioni con il mondo occidentale ma ha decisamente rallentato quelle con l’oriente. Nei rapporti con gli investitori statunitensi, le video call hanno egregiamente supplito all’impossibilità di spostamento tra le nazioni. Con il lato est del mondo, invece, nella nostra esperienza, si sono alzate delle barriere probabilmente dovute al fatto che le differenze linguistiche, ma sicuramente anche quelle culturali, rendono le relazioni in presenza più necessarie.
Questo ha di fatto mantenuto il nostro baricentro a ovest, tanto che alla fine ci siamo quotati al Nasdaq, e lo abbiamo fatto rimanendo fisicamente in Italia. Inizialmente abbiamo anche valutato l’idea di una quotazione a Hong Kong, spinti anche dal fatto che tra i nostri investitori figura Qianzhang Investment, con sede a Shangai, che è stato co-lead investor del terzo round di investimento privato, anno 2019, e che ci ha permesso di capire e avvicinarci al mercato cinese.
Questo spostamento che impatto ha avuto sui vostri rapporti con la Cina?
Positivo, almeno a giudicare dalla reazione del nostro socio cinese. Tradizionalmente, gli investitori cinesi si rivolgono o al mercato casalingo o a quello americano, raramente prendono in considerazione l’Europa. Negli ultimi anni, la situazione si è parzialmente modificata a favore dell’Europa ma la quotazione sul mercato americano resta un ancora risultato grandioso per i cinesi. Va anche detto che parliamo di investitori con una certa consuetudine alle operazioni internazionali: Qianzhang è stato uno degli investitori di Tencent music, la spotify cinese che si è quotata al Nyse.
Come riuscite a gestire la comunicazione nel contesto Usa?
In effetti si tratta di un punto critico: in Italia la nostra è una storia molto raccontata perché è un successo italiano e siamo gli unici quotati al Nasdaq. In America è molto più complesso avere un livello di visibilità vagamente paragonabile perché in questo mercato sono presenti 800 biotech quotate, molte delle quali di altissimo livello. In questo contesto risulta difficile trovare un elemento distintivo che attiri l’attenzione dei media, generalmente abituati a realtà di livello planetario come Tesla, Alphabet, Apple. Quello che possiamo valorizzare per farci conoscere sono gli interventi dei nostri scienziati – che sono molto conosciuti anche negli Stati Uniti – ai vari congressi scientifici americani per presentare dati, risultati delle sperimentazioni, e quindi anche la società e la community. Questo ci permette di avere visibilità in modo verticale nella comunità scientifica americana e nel settore della salute, che è poi il target che ci interessa.