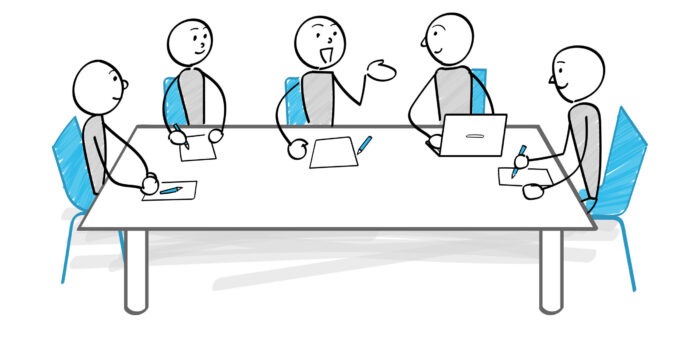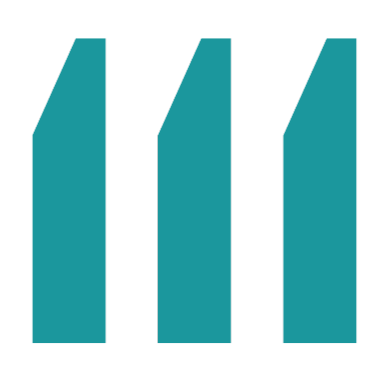A cosa servono i comitati etici sulle sperimentazioni? A fare in modo che certe aberrazioni non possano mai più avvenire. Il caso più noto è stato quello degli esperimenti medici effettuati nei lager nazisti, i cui responsabili furono condannati durante il processo di Norimberga per crimini contro l’umanità. Ma le violazioni dei diritti umani nel nome della ricerca scientifica furono numerose. Un esempio si rintraccia nel Tuskegee study, svolto dal 1930 al 1972, durante il quale quasi 400 uomini di colore affetti da sifilide vennero lasciati morire senza alcuna terapia per studiare il decorso della malattia.
Una lunga storia
Nel 1966 Henry Beecher, professore di anestesiologia all’Università di Harvard, pubblicò un noto articolo nel quale stigmatizzava, dati alla mano, il comportamento di ricercatori che avevano incluso in studi rischiosi i pazienti senza informarli. L’anno successivo l’eticista britannico Maurice Henry Pappworth denunciò centinaia di sperimentazioni, condotte in circostanze simili, che coinvolgevano adulti e bambini, e diede alle stampe il saggio Cavie umane: la sperimentazione sull’uomo. Proprio da questi presupposti cominciarono a diffondersi, negli anni Sessanta, i primi comitati etici sulle sperimentazioni. Prima negli Stati Uniti, poi in Europa, quindi in Italia.
Nel nostro Paese, in particolare, questi organismi sono stati istituiti con il decreto ministeriale del 18 marzo 1998, che ne ha formalizzato la presenza in tutte le strutture assistenziali. Nel 2006, il decreto ministeriale del 12 maggio ha poi stabilito i requisiti minimi dei comitati, inclusa la loro composizione.
È in questo momento che fa capolino, al fianco di clinici, medici di medicina generale, farmacologi, farmacisti, infermieri e altri esperti, anche la figura del paziente. Quest’ultimo è definito, come recita l’articolo 2, comma 4, «un rappresentante del volontariato per l’assistenza o dell’associazionismo di tutela dei pazienti». Un’eterogeneità che prevede, da una parte, la presenza di membri tecnici, dall’altra di quelli laici. Una composizione “mista” mirata a favorire la compenetrazione di diverse prospettive, il confronto, il pluralismo delle visioni, incrinando una cortina che spesso segmenta, separa e divide. Presupposti fondamentali, perché questo si concretizzi, è l’assenza di gerarchie e di poteri e la disponibilità all’ascolto reciproco.
Il rischio di un ruolo marginale
In concreto, le responsabilità e i ruoli del rappresentante dei cittadini-pazienti sono molto variabili e possono includere queste funzioni:
- contribuire alla valutazione del protocollo di ricerca
- valutare l’eticità degli studi considerando sia la rilevanza per i pazienti e per la ricerca, sia il rapporto tra rischio e beneficio
- tutelare la sicurezza e i diritti degli assistiti e la riservatezza dei dati
- verificare le informazioni fornite ai pazienti, per quanto riguarda sia le finalità della ricerca, sia la chiarezza e completezza del consenso informato
- esprimere un parere in merito all’approvazione o al rifiuto dello studio in esame
Tuttavia, all’atto pratico, spesso accade che il tutto si riduca a un compito informativo o poco più. Ciò a causa del fatto che, pur essendo consapevoli del proprio mandato, molte volte i membri laici non riescono a essere sufficientemente attivi nelle discussioni durante le riunioni. Di conseguenza non sono in grado nemmeno di concretizzare le proprie richieste e le proprie istanze. In mancanza di adeguati strumenti per argomentare, finiscono, insomma, per avere un ruolo marginale e residuale.
Alcune indagini sui comitati etici dal punto di vista dei pazienti…
Tutto questo è confermato da alcune indagini che, pur non essendo recentissime, sono le uniche al momento a disposizione.
Nel 2004 gli esperti dell’Università di Padova hanno svolto una ricerca inviando a 64 comitati etici sul territorio nazionale un questionario composto da 16 domande. Delle 33 persone che hanno risposto, 20 uomini e 13 donne – la maggior parte pensionati di età superiore ai 60 anni – la metà ha dichiarato che, prima di entrare a fare parte del comitato etico, non sapeva di che cosa si trattasse e non ne aveva mai sentito parlare. Oltre la metà, inoltre, ha affermato di sentirsi in una condizione di subalternità rispetto agli altri membri. Il 6% ha riferito di non riuscire a fare valere le proprie opinioni e il 36% di riuscirci solo in parte.
E ancora, il 18% ha ritenuto di non ricoprire un ruolo definito e ha espresso queste motivazioni: «Mi trovo in difficoltà a esprimere le mie idee», «non mi sento a mio agio con gli altri componenti del gruppo», «gli altri membri mi sottovalutano perché non ho competenze scientifiche». L’82% ha dichiarato che il proprio compito è, di fatto, circoscritto a ciò che riguarda il consenso informato per il paziente e si traduce nel verificare completezza, chiarezza e comprensibilità dei moduli. Infine, il 75% ritiene che nel comitato etico ci dovrebbero essere più persone che rappresentano i cittadini.
Una successiva indagine, svolta nel 2008 da Partecipa Salute, ha coinvolto 136 associazioni di pazienti, di cui 47 rispondenti. Ha mostrato che solo il 32% degli assistiti ritiene che le ricerche svolte nei precedenti cinque anni rispondano ai bisogni dei pazienti per rilevanza del quesito clinico e solo il 23% per rilevanza dell’esito misurato.
…e dal punto di vista dei tecnici
Sul fronte opposto, i tecnici non sempre percepiscono favorevolmente la presenza di un componente laico nel comitato. In una ricerca pubblicata nel 2006 sullo European Journal of Cancer Prevention è stato chiesto a 83 oncologi quale fosse la funzione del paziente nel comitato etico. Il 63% lo riteneva fondamentale per tutti gli aspetti. Il 22% riteneva il suo ruolo solo formale, nella convinzione che al rappresentante delle associazioni mancassero le nozioni tecnico-scientifiche per fornire un contributo significativo al dibattito. Il 15% lo riteneva fondamentale, ma solo relativamente ad alcuni aspetti, per esempio il consenso informato e l’informazione ai pazienti.
Servono informazione e lavoro in “rete”
Davanti a questi dati, è evidente che qualcosa è necessario fare.
«Si dovrebbe investire maggiormente sulla formazione del rappresentante dei pazienti, in modo da incrementarne le competenze, attraverso convegni, workshop, seminari che possono essere organizzati dalle società scientifiche e dalle istituzioni nazionali», sostiene Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva e da marzo membro del comitato etico dell’Istituto superiore di sanità.
«Tale attività formativa dovrebbe essere svolta sia prima dell’ingresso all’interno del comitato, sia in itinere, in modo da favorire l’aggiornamento sulle terapie avanzate e innovative, basate anche sulla genetica e sulla genomica. Inoltre, potrebbe essere utile implementare una “rete” sia tra i rappresentanti dei cittadini nei vari comitati, sia con la comunità di riferimento, creando degli spazi di dialogo e confronto. In aggiunta, in occasione della valutazione di un protocollo sperimentale, si potrebbe invitare al comitato il rappresentante dell’associazione dei pazienti a cui lo studio è rivolto. È importante che queste strutture non siano organismi burocratici deputati solo a garantire la correttezza delle procedure e il rispetto delle tempistiche, ma conservino il ruolo di garanti pubblici della tutela dei pazienti, riflettendo una nuova cultura dell’assistenza sanitaria fondata su informazione, autonomia, democraticità, trasparenza».
Così facendo, i comitati etici potrebbero davvero diventare un anello di congiunzione, un trait d’union tra scienza e società, in cui il malato recupera il proprio ruolo di soggetto portatore di valori, esperienze, competenze.